Questo è il blog del prof. FabioTar che ivi raccoglie materiale didattico, pensieri sparsi e meditabondazioni.
07 novembre 2009
Ma io difendo quella croce
[estratto] di Marco Travaglio
da “Il Fatto Quotidiano” di giovedì 5 novembre 2009
05 novembre 2009
Il vuoto spaventoso
Mi fa pochi problemi che non ci siano crocefissi sulle pareti di un'aula; mi fa invece molto problema che ci sia qualcuno che mi impedisca di metterli.
Di fatto quel qualcuno non mi sta dicendo che, per pluralismo, non ci devono essere simboli religiosi sulle pareti; mi sta dicendo che ce ne deve essere uno solo. il Grande Nulla, adorato da quanti si oppongono al bene in ogni sua forma.
Diffidate di chi odia il volto delle cose, il vostro volto. Una volta rimossa di una persona la storia, i simboli, ogni apparenza che non sia il grigio nulla, non resterà che uno spazio vuoto a forma di uomo. E si sa, il vuoto è destinato ad essere riempito.
La Corte europea dei diritti dell'uomo:
La Corte europea dei diritti dell'uomo:
«L'insegnamento dell'italiano» nelle aule scolastiche costituisce «una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni» e una violazione alla «libertà di cultura degli alunni». Così la Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'ultima sentenza. L'Italia ha ora tre mesi di tempo per adeguarsi.
Questo pronunciamento arriva dopo la sentenza sul crocefisso nelle aule, sul divieto di cartine geografiche sui muri delle stesse "che potrebbero offendere profondamente le sensibilità degli alunni di diversa nazionalità", sulla proibizione di mostrare "opere cosiddette artistiche che urtano la fede o la mancanza della tale" (escluso dall'insegnamento ogni dipinto o testo con riferimenti religiosi), il discusso comma sulla "non specificazione di genere" che ha bandito ogni riferimento al sesso delle persone in qualsiasi contesto storico o geografico, l'atto sulla "difformità storica" che proibisce l'insegnamento di una specifica circostanza che non sia "approvata in via preventiva come antirazzista, non eurocentrica e non in conflitto con qualsivoglia impostazione culturale", e il comma sull'educazione civica vista come "non vincolante e oppressiva per gli appartenenti a diversa cultura".
In conformità a queste direttive i bambini rigorosamente anonimi e in grembiulini unisex grigi - per via della discriminazione e della privacy - in mancanza di altre materie di studio possibili venivano istruiti solo in matematica e, fino ad oggi, in italiano.
Molti commentatori pensano che, poichè l'italiano è bandito, l'unica opportunità rimasta sia l'apprendimento della matematica tramite video dei teletubbies.
Una persona che potrebbe essere un funzionario del ministero della pubblica Istruzione - il burqa ha reso impossibile verificarne l'identità - ha riferito che si starebbero valutando strade alternative, come far dichiarare gli italiani minoranza protetta e quindi sfruttare gli appositi canali comunitari per insegnarlo almeno come lingua straniera. In fondo, precisa la presunta fonte ministeriale, vista la crisi delle nascite e l'obbligo comunitario della presenza di distributori di droghe, profilattici e pillole abortive fin nella scuola materna, il problema entro qualche anno si risolverà da solo.

04 novembre 2009
| Crocifisso/ I presidi:In Italia non possono essere tolti da aule |  |  |  |
| Il conflitto tra Stato e Chiesa mentre si faceva l'Italia |  |  |  |
| Scritto da Administrator | |
| lunedì 11 agosto 2008 | |
| La rivista dei padri serviti "Studi Storici dell'Ordine dei Servi di Maria" ha pubblicato nel suo ultimo fascicolo gli atti del convegno "Ordini religiosi fra soppressione e ripresa (1848-1950)" tenutosi a Roma nel 2006. Riportiamo un'ampia sintesi della relazione che apre il volume. di Gianpaolo Romanato Il travagliato problema dei rapporti fra Stato e Chiesa è uno dei principali fili conduttori della storia italiana, pre e post-unitaria. Man mano che gli studi progredivano ci si è accorti che quel lontano conflitto - un conflitto che riemerge continuamente - per una sorta di eterogenesi dei fini ha conseguito risultati diversi da quelli sperati o temuti. Mentre si paventava il crollo delle istituzioni ecclesiastiche, e in particolare degli ordini religiosi, questi hanno conosciuto un'imprevista rinascita, attraverso l'erompere di quel fenomeno delle nuove congregazioni, maschili e soprattutto femminili, sulle quali la storiografia più recente, stimolata dagli studi pionieristici di padre Giancarlo Rocca, sta lavorando con risultati di grande interesse.  La lotta agli ordini religiosi veniva da lontano. Era stata uno dei principali obiettivi della politica giurisdizionalista settecentesca, condivisa da qualificati uomini di Chiesa, basti pensare al Muratori e, nel XVIi secolo, a Paolo Sarpi. L'abnorme proliferazione di monaci e frati, l'ozio, l'inosservanza di norme fondamentali della vita regolare sono temi frequenti, sotto forma di denuncia più o meno aspra, nella letteratura del tempo (...). Le soppressioni napoleoniche furono così l'epilogo di un braccio di ferro che era durato molti decenni. Bisogna aggiungere che la crisi della vita religiosa era indipendente dagli interventi dell'autorità politica e ben nota alla Santa Sede. Pio ix, proprio per rimediare a questo degrado, istituì la Congregazione sullo Stato degli Ordini Regolari (enciclica Ubi primum, del 1847). La lotta agli ordini religiosi veniva da lontano. Era stata uno dei principali obiettivi della politica giurisdizionalista settecentesca, condivisa da qualificati uomini di Chiesa, basti pensare al Muratori e, nel XVIi secolo, a Paolo Sarpi. L'abnorme proliferazione di monaci e frati, l'ozio, l'inosservanza di norme fondamentali della vita regolare sono temi frequenti, sotto forma di denuncia più o meno aspra, nella letteratura del tempo (...). Le soppressioni napoleoniche furono così l'epilogo di un braccio di ferro che era durato molti decenni. Bisogna aggiungere che la crisi della vita religiosa era indipendente dagli interventi dell'autorità politica e ben nota alla Santa Sede. Pio ix, proprio per rimediare a questo degrado, istituì la Congregazione sullo Stato degli Ordini Regolari (enciclica Ubi primum, del 1847).La situazione mutò a partire dal 1848. Come è noto, fu la politica piemontese negli anni successivi a quella data che impostò le grandi linee del quadro legislativo, in materia ecclesiastica, esteso poi all'Italia dopo l'unificazione. La storiografia ha ben individuato le due tendenze presenti in tale politica: una prima tendenza separatista, volta a eliminare privilegi ed esenzioni, secondo le esigenze dei moderni Stati liberali, e a ridurre la Chiesa all'interno del diritto comune, come imponeva l'obiettivo di allineare il Piemonte agli standard europei; una seconda tendenza neogiurisdizionalista la quale, non avendo più a sua giustificazione l'unione Stato-Chiesa vigente nel Settecento, ha assunto il volto contrario di un "privilegio odioso e negativo" - per usare un'espressione di Pietro A. d'Avack - di un'ingerenza dello Stato nella Chiesa, o forse, a dirla più chiaramente, di un sopruso, di intonazione nettamente anticlericale. Di queste due tendenze, vincitrice fu la seconda, con conseguenze di grande rilievo sulla storia successiva. Alla prima tendenza appartiene la legge Siccardi n. 11013 del 9 aprile 1850, volta a sopprimere l'autonomia del foro ecclesiastico in ogni genere di controversia o processo, cioè il diritto degli ecclesiastici a godere di un trattamento giudiziario separato rispetto al resto dei cittadini, nonché a sopprimere il diritto di asilo nelle chiese e nei luoghi immuni.  Nella seconda tendenza rientra invece la legge 21 luglio 1848 che entrò in vigore con il Regio Decreto n. 777 del 25 agosto. Prescriveva la soppressione della Compagnia di Gesù, l'esproprio dei suoi beni, l'espulsione dei gesuiti "non regnicoli", cioè stranieri, l'obbligo per i "regnicoli" di uscire dall'ordine. Analoga sorte toccava alle Dame del Sacro Cuore, largamente diffuse nella Savoia. Nella seconda tendenza rientra invece la legge 21 luglio 1848 che entrò in vigore con il Regio Decreto n. 777 del 25 agosto. Prescriveva la soppressione della Compagnia di Gesù, l'esproprio dei suoi beni, l'espulsione dei gesuiti "non regnicoli", cioè stranieri, l'obbligo per i "regnicoli" di uscire dall'ordine. Analoga sorte toccava alle Dame del Sacro Cuore, largamente diffuse nella Savoia.I gesuiti erano in crisi dovunque ed erano stati scacciati da molte città in vari Stati italiani. In Svizzera, dopo la guerra del Sonderbund, la loro esclusione dal territorio federale era stata prevista addirittura da un articolo della Costituzione. Lo scopo della legge piemontese era dunque di eliminare non tanto un ordine religioso quanto un'associazione politica internazionale dipendente dall'estero, una setta, come venne definita nel corso del dibattito parlamentare, che si temeva praticasse propositi antinazionali. Cionondimeno, si trattò di un provvedimento grave, anche a causa della sua inutile estensione alle religiose del Sacro Cuore, che smentiva i presupposti liberali sui quali il Piemonte stava costruendo il proprio edificio costituzionale. Del medesimo tenore fu la legge Siccardi n. 1037 del 5 giugno 1850: essa proibiva ai "corpi morali, siano ecclesiastici o laicali", di "acquistare" beni immobili o accettare "donazioni tra vivi" oppure "disposizioni testamentarie a loro favore" senza l'autorizzazione o l'assenso governativi. Anche questa norma sarebbe entrata a far parte del successivo ordinamento italiano. La terza legge piemontese di intonazione neogiurisdizionalista, quella di gran lunga più rilevante, presentata da Cavour e Rattazzi il 28 novembre 1854, fu oggetto di una discussione eccezionalmente intensa e appassionata. Con questo provvedimento cessavano di "esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato degli enti religiosi i quali non attendono alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degli infermi". Un decreto coevo (n. 879) elencava nominativamente gli ordini soppressi: 21 maschili e 13 femminili, per un complesso di 335 case e 5489 persone, 3733 uomini e 1756 donne. Dei provvedimenti piemontesi in materia ecclesiastica, fu questo a suscitare le polemiche più accese, che coinvolsero e appassionarono tutto il Paese, con petizioni pro e contro. Rosario Romeo ha fatto notare che la petizione contraria venne sottoscritta da un numero di cittadini - circa 69.000 - di gran lunga superiore non solo a quanti firmarono la petizione a favore - 12.629 - ma anche al numero dei votanti in tutte le tornate elettorali successive alla concessione dello Statuto. 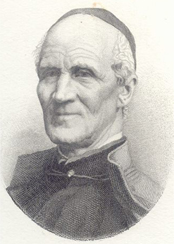 Il Piemonte cattolico era stato sconfitto dall'anticlericalismo intransigente della sinistra di Urbano Rattazzi, alla quale lo stesso Cavour aveva pagato un prezzo elevato. Sempre secondo Romeo, infatti, la legge del 1855 "rappresentò lo scostamento più sensibile" dalla politica liberale e separatista della formula "libera Chiesa in libero Stato". Scostamento che ebbe un effetto probabilmente non previsto dal legislatore: quello di aprire una breccia, di creare un precedente. La strada seguita allora, tutto sommato con cautela, diverrà la strada maestra della politica ecclesiastica italiana, ma senza più quelle prudenze. La linea anticlericale aveva vinto una battaglia decisiva. Il Piemonte cattolico era stato sconfitto dall'anticlericalismo intransigente della sinistra di Urbano Rattazzi, alla quale lo stesso Cavour aveva pagato un prezzo elevato. Sempre secondo Romeo, infatti, la legge del 1855 "rappresentò lo scostamento più sensibile" dalla politica liberale e separatista della formula "libera Chiesa in libero Stato". Scostamento che ebbe un effetto probabilmente non previsto dal legislatore: quello di aprire una breccia, di creare un precedente. La strada seguita allora, tutto sommato con cautela, diverrà la strada maestra della politica ecclesiastica italiana, ma senza più quelle prudenze. La linea anticlericale aveva vinto una battaglia decisiva.Questo complesso di leggi, più altre di minore importanza ma del medesimo tenore, fu esteso ai territori via via annessi nel biennio 1859-61, territori nei quali vennero abrogati i concordati in vigore, incluso quello con l'Austria del 1855, soppressione giustificata in base alla considerazione che i concordati legavano i precedenti sovrani e non il nuovo Governo. Dopo l'unificazione il quadro legislativo si presentava disorganico e incoerente. La legislazione piemontese era stata applicata in fretta e in maniera non uniforme. C'erano ordini che si erano salvati e altri, come i gesuiti, che erano stati quasi azzerati. Il trattato di Zurigo - 10 novembre 1860 - prevedeva che le proprietà dei religiosi non potessero essere toccate e quindi in Lombardia non fu applicata la legge del 1855. Occorreva riordinare, rimediare a disuguaglianze, disparità, incongruenze. Il codice civile si pose su questa via. Ma l'inasprirsi dei rapporti con il Pontefice, l'impossibilità di trovare una via di intesa, rafforzò le posizioni della Sinistra, le sue richieste di una politica ecclesiastica meno conciliante e più decisa, la sensazione che, se non si fosse limitato il potere e l'autonomia della Chiesa, lo Stato avrebbe corso seri rischi. Uno dei campi di lotta preferiti fu perciò quello della libertà di associazione, soprattutto in rapporto agli istituti religiosi. La loro presenza sul territorio, vecchia spesso di secoli, il loro radicamento sociale, il rapporto stretto con la popolazione, li rendevano uno degli anelli principali di una catena di potere e di sudditanza che si riteneva di dover spezzare. Molti di loro, poi, disponendo di patrimoni cospicui e vistosi, richiamarono l'attenzione governativa, mano a mano che si allargava la crisi finanziaria dello Stato. Lotta politica e necessità di bilancio crearono così la miscela da cui prese vita l'azione legislativa, nel presupposto che gli enti morali non possiedano la capacità di acquistare e possedere se non attraverso la personalità giuridica loro concessa dallo Stato. E come lo Stato la concede, con il medesimo diritto la toglie. Sotto l'urgenza sempre più pressante del deficit di bilancio si giunse così al progetto che poi diverrà la legge n. 3096 del 7 luglio 1866, frettolosamente approvato dalla sola Camera e varato dal Governo senza l'approvazione del Senato, in virtù dei poteri speciali accordatigli dallo stato di guerra contro l'Austria. Con tale legge, non erano più riconosciuti dallo Stato "gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari e i conservatori e ritiri i quali apportino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico". 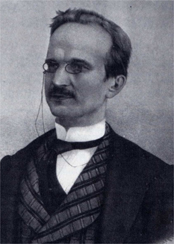 Si noti la scomparsa della distinzione fra istituti di vita contemplativa e di vita attiva, presente nel testo piemontese del 1855, distinzione che, se non altro, forniva un criterio. Venivano soppresse le relative case; ai membri delle comunità cancellate venivano riconosciuti i diritti civili e politici e una pensione annua; le monache potevano continuare a vivere nelle loro sedi, ma, se ridotte a sei, potevano essere trasferite e concentrate altrove a discrezione del Governo, che comunque, "in ogni tempo", si riservava tale facoltà, "per esigenze di ordine o di servizio pubblico". Ogni forma di resistenza sarebbe stata punita conformemente alle "leggi penali vigenti". Si noti la scomparsa della distinzione fra istituti di vita contemplativa e di vita attiva, presente nel testo piemontese del 1855, distinzione che, se non altro, forniva un criterio. Venivano soppresse le relative case; ai membri delle comunità cancellate venivano riconosciuti i diritti civili e politici e una pensione annua; le monache potevano continuare a vivere nelle loro sedi, ma, se ridotte a sei, potevano essere trasferite e concentrate altrove a discrezione del Governo, che comunque, "in ogni tempo", si riservava tale facoltà, "per esigenze di ordine o di servizio pubblico". Ogni forma di resistenza sarebbe stata punita conformemente alle "leggi penali vigenti".Il carattere sostanzialmente vessatorio della legge è evidente soprattutto in questi articoli, che capovolgono la realtà facendo della vittima un potenziale colpevole, obbligandolo ad avere parte attiva in tutta l'operazione volta a eliminarlo. I comuni erano autorizzati a chiedere in via prioritaria la concessione dei fabbricati espropriati per fini comprovati di pubblica utilità. I beni artistici - libri, manoscritti, documenti, opere d'arte - erano devoluti a musei e biblioteche della provincia rispettiva. Erano esentati dalla requisizione soltanto gli stabilimenti ecclesiastici "distinti per la monumentale importanza": Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala, Monreale, Certosa di Pavia. Abbazie di non minore significato, penso a quella veneta di Praglia, tentarono inutilmente di ancorarsi a questa norma, che contemplava la possibilità di mantenere in vita anche "altri simili stabilimenti ecclesiastici". La legge era stata ispirata esclusivamente dalle ragioni dell'interesse finanziario, come notarono molti parlamentari contrari al provvedimento. Le stesse ragioni che furono all'origine della seconda legge, successiva di un anno, la n. 3848 del 15 agosto 1867. Essa estendeva il criterio di soppressione agli enti secolari, con il criterio di mantenere in vita solo quelli con potere di governo o dediti alla cura d'anime. I beni confiscati erano devoluti al demanio. Con questo secondo provvedimento, la decapitazione dell'istituzione ecclesiastica, non più limitata agli ordini regolari ma estesa alle istituzioni secolari, poteva dirsi compiuta. Resta da segnalare, per completare l'edificio legislativo di questi anni, la legge varata per la provincia di Roma dopo il 20 settembre, sulla quale possediamo l'ampio studio di Carlo Fiorentino. La situazione della capitale era diversa da quella del resto del Paese e consigliava di andare molto cauti. A Roma c'erano le curie generalizie degli ordini religiosi, competenti sui regolari di tutto il mondo, molte guidate da ecclesiastici non italiani. C'erano complessi problemi di giurisdizione e di titolarità, legate ai diritti che stati esteri potevano vantare sugli immobili, sulla loro destinazione d'uso e sulle persone che li abitavano. C'erano biblioteche e archivi imponenti, risalenti ai tempi più antichi. Inoltre l'estensione della proprietà ecclesiastica, costituita da immobili posti nel centro di Roma e di terreni ubicati fuori della città, rendeva da un lato inevitabile e dall'altro estremamente complesso e difficile ogni intervento di esproprio. Un mese prima dell'annessione il ministro degli esteri Visconti Venosta incaricò le rappresentanze italiane all'estero di informare i Governi presso i quali operavano, delle intenzioni su Roma. Per prevenire proteste e tensioni sul fronte internazionale, i nostri diplomatici erano autorizzati a dare assicurazioni che l'Italia avrebbe rispettato la proprietà ecclesiastica, sgravandola da imposte. Altri autorevoli politici si espressero negli stessi termini. Ma il disinteresse internazionale per le sorti dello Stato pontificio diede forza ad altri orientamenti. Inoltre i nuovi ceti mercantili, che nel crollo del vecchio regime e nell'esautorazione della classe dirigente pontificia avevano subito individuato la possibilità di giganteschi affari, tanto in città quanto nel contado, premettero per una politica più determinata. Gli espropri per esigenze di "pubblica utilità", autorizzati dall'articolo 4 della legge del 3 febbraio 1871 sul trasferimento della capitale a Roma, iniziarono con il Collegio Romano dei gesuiti, una delle scuole più gloriose d'Europa, dove avevano studiato o insegnato protagonisti indiscussi della storia moderna, da Cristoforo Clavio a Matteo Ricci. Era il preannuncio di come si sarebbe proceduto. Si giunse così alla legge del 1873. La formulazione primitiva prevedeva che le case religiose aventi a Roma il generale conservassero una sede per la sua residenza e la rappresentanza presso la Santa Sede. Ma non fu accolta perché, implicitamente, ammetteva la diversità di Roma rispetto al resto del Paese. Il testo definitivo della legge - la 1402 del 19 giugno 1873 - passò con un emendamento decisivo proposto da Ricasoli all'articolo 2 sulla questione delle case generalizie. L'emendamento contemplava che alla Santa Sede fosse assegnata una rendita per il mantenimento del generalato e la conservazione dei locali di residenza. Ma l'articolo 4 escludeva il "rappresentante dell'ordine dei gesuiti" da tale beneficio. Al generale della Compagnia, il belga Pierre-Jean Beckx, andò la concreta solidarietà dei superiori di tutti gli altri ordini. I religiosi colpiti dal provvedimento furono 2888: 1034 uomini e 1069 donne. Tuttavia la sua applicazione fu assai complicata, anche per la complessità dei palazzi coinvolti nel provvedimento. Un capitolo a sé è quello che riguarda la vendita all'asta dei lotti di terreno dell'agro romano. L'intero territorio dello Stato pontificio, estinto nel 1870, era stato riunito per il momento sotto una sola amministrazione provinciale, quella di Roma, l'unica in grado di far fronte alle esigenze della bonifica e dell'urbanizzazione del territorio. L'operazione fu un generale fallimento, tanto che la campagna romana conobbe una regressione che durerà fino al fascismo. Il risultato delle aste non andò mai a vantaggio dei piccoli coltivatori ma servì solo a incrementare il latifondo e la speculazione mercantile. Ci furono inoltre innumerevoli contenziosi, anche con Stati esteri che vantavano diritti di proprietà su edifici confiscati, in particolare con la Francia e la Spagna. Addirittura la Russia e la Turchia ebbero buone ragioni per contestare lo sbrigativo procedere del Governo sabaudo nella requisizione di stabili che andavano a beneficio di cittadini di quei Paesi, tanto ecclesiastici quanto laici. Un discorso a parte, se non ci portasse troppo oltre il nostro assunto, meriterebbe il destino di archivi e biblioteche, prevalentemente di argomento ascetico e teologico, inadatte a destinazioni diverse da quelle per le quali erano nate, ma ugualmente requisite. La fretta e la mancanza di progetti provocò irreparabili dispersioni, mentre in diversi casi ai religiosi vennero confiscate anche le biblioteche personali. Pur avendo ricevuto un colpo durissimo gli ordini religiosi sopravvissero e si riorganizzarono. Colsero anzi l'occasione per purificare la loro vita interna e per riscoprire la vocazione originaria e un rinnovato legame di fedeltà e sottomissione alla Santa Sede. Nel 1895 Crispi pensò probabilmente a un nuovo giro di vite contro ordini e congregazioni religiose. Ordinò perciò agli organi dello Stato un'inchiesta su scala nazionale per censire associazioni, corporazioni e sodalizi a carattere religioso presenti in Italia. Il censimento fu condotto riservatamente dalle prefetture, che si servirono dei carabinieri. Non furono interpellati i diretti interessati, ciò che portò a forzature ed errori, inoltre i dati che ci sono pervenuti non sono completi, essendo mancanti quelli relativi a città come Milano, Brescia e Bergamo, dove la presenza di queste istituzioni era molto forte. Cionondimeno, ne emerge una realtà molto maggiore di quanto si poteva pensare: complessivamente furono segnalate 3122 istituzioni presenti nel Paese, uniformemente distribuite fra nord, centro e sud (rispettivamente 868, 741 e 1014, mentre 499 erano presenti a Roma). Un terzo di queste istituzioni risultavano impegnate nel sociale: scuola, assistenza e così via. Dall'indagine governativa risultava insomma una vitalità del tutto imprevista, la stessa vitalità che la storiografia recente ha puntualmente confermato con i suoi studi prima sul movimento cattolico e poi sulle nuove congregazioni religiose. Quelle - maschili e soprattutto femminili, di vita attiva e non contemplativa, di voti semplici e non solenni, per lo più di semplice diritto diocesano, almeno nella fase iniziale - che fiorirono in gran copia in Italia durante tutto l'Ottocento, proprio mentre era in atto la battaglia governativa per sopprimere i vecchi ordini, protette da quella libertà di associazione che era garantita a tutti i cittadini. Nel discorso che ho ricordato nell'esordio, Crispi si riferiva probabilmente ai risultati di questa inchiesta affermando allarmato che l'associazionismo religioso stava crescendo più rigogliosamente che nell'antico regime. E aggiunse: "Questo è un fatto. Di chi la colpa? La colpa è della legislazione, la quale lascia alla Chiesa cattolica una illimitata libertà. Se ritenete che la libertà non produca questo fatto, credo che siate in errore. Ma - continuò - non si provvede ad un problema simile con gli attacchi, con i rumori, con le grida, con quel genere di proteste che non producono se non discordie. Si provvede con una legislazione savia e con l'accordo di tutti i partiti liberali". Quest'accordo c'era stato, pur con molti compromessi e accomodamenti, in Piemonte e nei primi anni dell'Italia unita. Non c'era più nell'Italia di fine secolo. Lo stesso Crispi, che l'anno dopo vedrà naufragare la propria carriera politica nell'inutile avventura africana, non osò, o non ebbe il tempo, per rimettere mano alla questione delle corporazioni religiose. La legge, probabilmente desiderata dal presidente del Consiglio, non si fece. Un'intera stagione di politica ecclesiastica si stava concludendo. Forse, se mi consentite un paragone calcistico, si concludeva con un pareggio. Lo Stato aveva conseguito lo scopo di riportare la vita religiosa all'interno del diritto comune. Questa era riuscita a sopravvivere e a rinnovarsi, adeguandosi ai tempi mutati. Ne era nato però un conflitto, un'autentica "guerra civile" secondo Ernesto Galli della Loggia, che ha segnato tutta la nostra storia nazionale. (©L'Osservatore Romano - 10 agosto 2008) |