 Girovagando per la rete, spinto anche dalle richieste di un lettore, mi sono «imbattuto» negli scritti di Luigi Cascioli, ex-sacerdote passato all’ateismo, che da anni ormai porta avanti una crociata contro la chiesa di Roma e contro il cristianesimo in generale, nel tentativo di dimostrare l’inconsistenza della fede cristiana. Ho quindi deciso di commentare in chiave critica alcuni suoi scritti, partendo dalle sue affermazioni relative ai Vangeli. Il primo testo del quale ci occuperemo è quello conosciuto come il «Vangelo secondo Marco».
Girovagando per la rete, spinto anche dalle richieste di un lettore, mi sono «imbattuto» negli scritti di Luigi Cascioli, ex-sacerdote passato all’ateismo, che da anni ormai porta avanti una crociata contro la chiesa di Roma e contro il cristianesimo in generale, nel tentativo di dimostrare l’inconsistenza della fede cristiana. Ho quindi deciso di commentare in chiave critica alcuni suoi scritti, partendo dalle sue affermazioni relative ai Vangeli. Il primo testo del quale ci occuperemo è quello conosciuto come il «Vangelo secondo Marco».
Perchè non seguire l’ordine canonico, iniziando da Matteo? Per il semplice fatto che, come avremo modo di vedere, il testo attribuito a Marco fu una delle basi sulle quali sia Matteo che Luca scrissero le rispettive narrazioni, riportandone molto del contenuto: ecco perchè questi tre Vangeli vengono anche chiamati «sinottici»; posizionando il testo di Marco, Luca e Matteo su tre colonne parallele, è possibile infatti seguire la narrazione in maniera armonica, notando con facilità le similitudini, anche a livello di esposizione. Vediamo prima una breve panoramica sul Vangelo, per poi affrontare le tesi del Cascioli. Buona lettura!
L’autore
Iniziamo spendendo alcune parole sull’autore di questo testo, per occuparci in seconda battuta della datazione del suo scritto: chi era «Marco»? La chiesa degli esordi associava la figura di questo evangelista con il personaggio di «Giovanni, detto Marco» del quale possiamo leggere nell’episodio di Atti 12:12. Si tratta di una figura «contesa», che fu al centro di una accesa disputa tra Paolo e Barnaba, allorquando dovettero decidere se portarlo con loro durante una missione (Atti 15:37-41).
Più tardi, Marco e Paolo superarono i dissapori sorti in tale occasione: prova ne sono due citazioni che l’apostolo delle genti rivolge (in accezione positiva) al giovane nelle epistole ai Colossesi (4:10) ed a Filemone (24). Inoltre, l’apostolo Pietro lo menziona con affetto nella sua prima epistola (5:13). La figura di Marco che emerge dal racconto biblico certamente non lo fa apparire come un personaggio particolarmente evidente, e con ogni probabilità – perlomeno, basandosi su quanto ipotizziamo del suo carattere – egli non avrebbe redatto il suo scritto in assenza di una ragione più che valida. Eusebio di Cesarea, vescovo e scrittore in lingua greca, riportando le parole del vescovo Papia indica Marco quale redattore dell’omonimo vangelo (Eusebius, Storia Ecclesiastica, III.39), vangelo nel quale, secondo la cristianità del II secolo, lo scrittore espose il pensiero dell’apostolo Pietro, al quale era molto legato, e del quale era discepolo[1] :
[1] «Marco, interprete di Pietro, riferì con precisione, ma disordinatamente, quanto ricordava dei detti e delle azioni compiute dal Signore. Non lo aveva infatti ascoltato di persona, ma, come ho detto, da Pietro; questi insegnava secondo le necessità, senza fare ordine nei detti del Signore. In nulla sbagliò perciò Marco nel riportarne alcuni come li ricordava. Di una cosa sola infatti si preoccupava, di non tralasciare alcunché di ciò che aveva ascoltato e di non riferire nulla di falso.»
Lo stile della narrazione, è poi una conferma del fatto che Marco non sia stato un testimone oculare del ministero di Cristo, anche se alcuni vorrebbero dare ad intendere questa ipotesi affermando che la citazione di un “ragazzo che fuggì nudo durante l’arresto di Gesù” (Marco 14:51-52) sia una sorta di cameo autobiografico, ma non abbiamo sufficienti prove per asserire questo aspetto con certezza, considerato anche che, come abbiamo visto, questo era scartato fin dagli albori del cristianesimo.
La datazione
La datazione precisa del Vangelo di Marco non è sicuramente compito facile, e questo a causa di ragioni differenti: anzitutto, vi sono pareri discordanti tra i vari padri della chiesa, e poi alcuni problemi sollevati dal testo stesso. Secondo il parere di Clemente Alessandrino (150 d.C. – 215 d.C.), fu Pietro a dettare personalmente il Vangelo a Marco, per approvare poi l’ultima stesura, mentre Ireneo (130 d.C. – 202 d.C.) afferma che lo scritto sia immediatamente posteriore alla morte di Pietro e di Paolo.
Le citate difficoltà del testo sono invece legate alle allusioni di Marco alle persecuzioni ed ai processi di cristiani: alcuni teorizzano che i lettori del testo dovettero sopportare la persecuzione a causa della loro fede, cosa che daterebbe il Vangelo di Marco negli anni 60-70 d.C., quando l’imperatore Nerone accusava i credenti dell’incendio di Roma. È però importante tenere a mente che nel I secolo la persecuzione era così usuale, che non è affatto detto che si stiano indicando le persecuzioni più note: sicuramente, vi furono persecuzioni più ridotte, anche locali, delle quali non sappiamo nulla. Questo pertanto non è un criterio affidabile per la datazione del testo.
Un’ulteriore accertamento da fare riguarda la cosiddetta «sezione apocalittica» di Marco, ossia il brano presente al capitolo 13, versetti da 1 a 37: determinare il rapporto tra tale narrazione e la caduta di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C. per opera delle armate di Tito, sarebbe un sicuro aiuto nel facilitare la datazione dello scritto. Vi sono studiosi che stimano la data di compilazione del Vangelo molto tempo prima del 70 d.C., mentre la maggioranza degli esperti è concorde nel datarlo tra il 45 d.C. ed il 60 d.C.. Una esigua minoranza si spinge poi fino al 70 d.C., e pochi altri asseriscono che esso fu redatto intorno all’80 d.C.
La tesi, e la risposta
Fatte queste premesse, che ci hanno permesso una introduzione all’ambito in cui Marco scrisse, passiamo a vedere quali siano le tesi di Cascioli, per discuterle alla luce di quello che sappiamo dalla Scrittura e dalla storia. In blu saranno scritti gli estratti del lavoro di Cascioli, mentre in nero, dopo ogni passaggio, riporterò le mie considerazioni in merito (con note a corredo):
Cascioli: Presentazione della Chiesa: «Marco, collaboratore di Pietro, che lo predilesse tanto da chiamarlo “suo figlio”, lo scrisse intorno al 65 per i fedeli di origine pagana; secondo la tradizione, per i cristiani di Roma». (C.E.I.). Anche se tutti gli esegeti sono d’accordo a ritenere che il vangelo di Marco sia uscito prima di quello di Matteo per la ragione che quest’ultimo lo ricopia in numerosi passi, esso è comunque da collocarsi ad una data posteriore al 150 per gli stessi motivi che sono stati portati per il vangelo di Matteo: il redattore è a conoscenza della disfatta di bar Kocheba (135) e Papia, vescovo di Geropoli verso il 150, dimostra di conoscerlo allorché lo qualifica come una raccolta di reminiscenze riportate senza alcun ordine cronologico: «Marco, interprete di Pietro, redasse esattamente ma senza ordine ciò che ricordava delle parole del Signore». Basterebbe soffermaci su questa definizione di Papia per determinare la tardività del vangelo di Marco.
SoloVangelo: Attaccando perfino la prefazione al Vangelo dell’edizione CEI, Cascioli mette in dubbio la datazione dello scritto, stimandolo come un’opera addirittura posteriore al 150 d.C.. Le sue motivazioni? Anzitutto, il fatto che, come abbiamo visto, Papia citi questo scritto. La vanità di questa tesi è sotto gli occhi di tutti, ma vogliamo fare un esempio pratico: se il ragionamento del Cascioli fosse valido, il fatto che, da qualche parte del mondo, venga ipoteticamente rinvenuto un testo autorevole del nostro secolo in cui si parla dell’Odissea, dovrebbe farci concludere che il poema di Omero deve essere datato intorno al 2000 d.C., suscitando ovviamente l’ilarità generale. È evidente che una tale tesi non può essere bollata in altro modo se non come «sciocchezza». Vediamo quindi come, contrariamente a quanto affermi il Cascioli, non sia affatto sufficiente soffermarsi sull’affermazione di Papia.
La seconda ipotesi dell’ex-sacerdote è che lo scrittore del Vangelo fosse evidentemente a conoscenza della rivolta di Bar Kochba (che il Cascioli chiama Bar Kocheba, probabilmente ignorando come si legga lo sêwa ebraico…); con ogni probabilità, egli fa questa ipotesi basandosi sul brano apocalittico di Marco 13 (visto poc’anzi), ma senza addurre nessuna prova per confermare che in quella porzione di Vangelo ci si stia riferendo alla disfatta dei Giudei ad opera dei Romani (135 d.C.). Piuttosto, ci pare di scorgere nelle parole di Gesù il cosiddetto «impianto predizionale»: Cristo, cioè, si riferisce all’imminente caduta di Gerusalemme del 60 d.C., espandendo poi il significato delle sue parole alla tribolazione apocalittica, la quale deve ancora verificarsi. Il fatto di voler poi criticare uno scritto evidentemente profetico sulla base di nozioni storiche posteriori è un artificio ingenuo: essendo Gesù l’incarnazione di Dio, era logicamente possibile per Lui esprimersi su fatti futuri senza avere quindi la necessità che i redattori delle sue parole fossero a conoscenza di tali eventi. Traducendo in altri termini, Cascioli non è in possesso di alcun dato che affermi la conoscenza, da parte di Marco, degli eventi del 135 d.C., e quindi non può affatto riferirsi alle sue supposizioni come a certezze.
Cascioli: Cos’altro si può dedurre da essa se non che il vangelo dichiarato canonico dalla Chiesa sia una derivazione dello pseudo-Marco, dal momento che esso, oltre che a riportare una biografia di Gesù, risulta anche essere il più ordinato di tutti i vangeli? «Il vangelo a cui si riferisce Papia dichiarandolo una raccolta di sentenze riportate senza alcun ordine non può essere quello che la Chiesa ci propone, perché nessuno dei vangeli ha un piano più coerente e studiato di quello di Marco» (Goguel – Intr. al Nuovo Vangelo). «Il vangelo di Marco è così ordinato che le sue parti, ben distinte fra loro, sono a loro volta divise per tre o in multipli di tre; Gesù è oltraggiato alle ore 3, condotto al Calvario alle ore 6 ed espira alle ore 9. Questa composizione, essendo tutto l’opposto dello pseudo-Marco a cui si riferisce Papia, non può essere stata scritta che da qualcuno che l’ha ricostruita e messa in ordine dopo il 150». (Prosper Alfaric ex professore di teologia presso i grandi seminari di Francia, convertitosi all’ateismo). «Il vangelo di Marco, come tutti gli altri vangeli canonici, non sono che un’elaborazione di quella raccolta di sentenze chiamate Logia che furono tratte dalle profezie bibliche riferentesi al Messia». (Rendel Harris – Testimonianze – Cambridge 1920 – Quaderno del Circolo Renan, 3° trim. 1961).
SoloVangelo: L’affermazione di Papia secondo cui le sentenze (logia) di Gesù sono riportate da Marco in ordine sparso, non significa certo che il testo debba essere illeggibile, oppure che presenti evidenti contraddizioni cronologiche. Facciamo un esempio: In Marco 9:37, Gesù pronuncia la celebre frase: «Chiunque riceve uno solo di questi piccoli nel mio nome, riceve me; e chiunque riceve me, non riceve me, ma Colui che mi ha mandato». Subito dopo, al versetto 38, leggiamo invece: «Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato, perchè non ti segue con noi». La domanda è la seguente: quali prove abbiamo per affermare che i due versetti siano da considerarsi come un corpus organico, pronunciati effettivamente con quella sequenza? Nessuna.
In effetti, parrebbe strano che mentre Gesù insegnava un concetto di una sicura valenza teologica come quello del versetto 37, uno dei suoi discepoli cambiasse improvvisamente discorso, per affrontare un argomento del tutto diverso!
C’è poi da dire che non siamo in possesso di alcun documento definibile come pseudo-Marco, essendo un tale scritto presente soltanto nelle congetture di chi si aspetterebbe che, dovendo essere un testo «non ordinato», il Vangelo di Marco debba essere il lavoro illetterato di un analfabeta! Chiaramente, nella stesura anche non cronologica di avvenimenti, si può (e si deve) seguire una struttura, altrimenti come si potrà rendere comprensibile il testo?
Vediamo inoltre che le fonti citate dal Cascioli appartengono ad una certa corrente viva agli inizi del XX secolo, la quale basava il suo pensiero sulla non-esistenza storica di Gesù. Oggi tale movimento, se non morto del tutto, è certamente decrepito, e sono soltanto gli sforzi di alcuni «nostalgici» a ritardarne la scomparsa definitiva. Il caso di Prosper Alfaric, giusto per citarne uno, è emblematico: sappiamo che fu il suo incontro con la filosofia a distruggere le promettenti basi che egli aveva come ministro cristiano, tanto da trasformarlo, fino alla sua morte avvenuta nel 1955, in uno dei pilastri dell’unione razionalista. Le sue sono le considerazioni di un uomo che è semplicemente passato da una categoria di pensiero ad un’altra.
Cascioli: Un’altra prova dimostrante ancora che il vangelo non è stato scritto da un ebreo quale era Marco, ma piuttosto da uno dei quegli esseni di origine pagana della comunità di Roma (Il vangelo di Marco fu scritto a Roma in lingua latina – Couchoud. Infra- pag.254), che si erano separati dall’essenismo per sostenere l’incarnazione di Cristo, ci viene dalla disconoscenza che costui ha della Bibbia allorché inizia il vangelo commettendo subito l’errore di attribuire l’annuncio del Messia al profeta Isaia (Mc.1,1), quando esso appartiene invece al profeta Malachia (3,1).
SoloVangelo: Sulla paternità del Vangelo di Marco abbiamo già discusso: tutta la cristianità primitiva, come abbiamo visto, era concorde nell’indicare nel discepolo di Pietro l’autore dello scritto. Le speculazioni su una probabile origine essenica di Marco non trovano conferma né nelle Scritture, né in alcun documento storico, rimanendo, pertanto, fumose illazioni. Il Cascioli vorrebbe invece affermare il contrario, additando un’ipotetica ignoranza scritturale (che sarebbe propria della comunità essena, la quale invece era versatissima nelle Scritture Antiche) che avrebbe condotto l’autore a commettere un “errore di citazione”, proprio in apertura della sua narrazione. Vediamo allora il passo “incriminato”:
«Inizio del vangelo di Gesù Cristo [Figlio di Dio]. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via…Voce di uno che grida nel deserto: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”». » (Marco 1:1-2)
In questo passo, Marco non sbaglia affatto citazione: infatti, vediamo che la citazione di Isaia 40:3 è correttamente indicata («Voce di uno che grida nel deserto: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”»), mentre invece omette di dire che la prima parte della frase è in effetti l’estratto da Malachia 3:1. Con ogni probabilità, Marco intendeva dare una maggiore enfasi all’adempimento della profezia cristologica di Isaia (definito anche l’«evangelista dell’Antico Testamento»), piuttosto che quella di Malachia, che è in evidente riferimento alla figura di Giovanni il Battista.
Cascioli: Ma di questi errori biblici e geografici che potevano essere commessi soltanto da truffatori che ignoravano la Bibbia e la Palestina ne sono così pieni i vangeli da suscitare più pietà che disprezzo. Soltanto Adel Smith, nel suo libro “500 Errori nella Bibbia” (Ed.Alethes), ne ha contati nei 4 vangeli canonici e negli Atti degli Apostoli ben 250. «Non sono che insignificanti inesattezze che servono a rafforzare la fede», rispondono i preti quando gli si fanno rimarcare!
SoloVangelo: Non mi dilungherò in una trattazione riguardante la bontà delle odierne traduzioni per non risultare eccessivamente «pesante», ma su questo punto è comunque necessario spendere alcune parole. In effetti, nelle rese moderne è spesso possibile trovare alcune imprecisioni dovute alla difficoltà di adattamento linguistico (tradurre lingue come il greco e l’ebraico in italiano, per esempio, non sempre è così immediato), ed è quindi evidente la necessità di approcciarsi, per quanto possibile, alle lingue originali: quando il cristiano afferma che la Parola di Dio è perfetta, non si sta certo riferendo alle traduzioni, ma al testo ispirato.
Le imprecisioni presenti ad oggi nel testo sono causate dalla ricopiatura dei manoscritti nel corso dei secoli. Ma attenzione: quando si parla di questi «errori», è necessario sapere che essi sono assolutamente ininfluenti sotto il profilo dottrinale, andando a colpire quelle parti di testo più specificatamente discorsive o narrative. Un piccolo esempio chiarirà le idee:
Nell’episodio descritto in 2 Samuele 8:4, i prigionieri catturati dal re Davide risultano essere millesettecento cavalieri, ventimila fanti, e cavalli per cento carri. Lo stesso avvenimento lo troviamo descritto in 1 Cronache 18:4, dove leggiamo che i prigionieri erano costituiti da settemila cavalieri, ventimila fanti, mille carri e cavalli per cento carri. La differenza tra i cavalieri è notevole, e studiosi come Keil e Delitsch spiegano che tali discrepanze sono probabilmente il frutto di errori di copisti, nel copiare – appunto – i caratteri ebraici. Non abbiamo comunque traccia di anomalie che minino il senso della Scrittura: essi si riducono a casi sporadici e tutto sommato irrilevanti come il suddetto, narrazione neotestamentaria inclusa.
Cascioli: Un’altra osservazione interessante riguardo l’autore del secondo vangelo ci viene da Guy Fau: «Come è possibile che sia stato Marco, l’apostolo tanto prediletto da Pietro da considerarlo come suo figlio, a scrivere questo vangelo quando egli tacendo il “ tu es Petrus” che troviamo negli altri vangeli, dimostra di ignorare che Gesù lo aveva eletto capo della Chiesa?».
SoloVangelo: Quest’osservazione nasce anzitutto da una cattiva comprensione della frase «tu sei Pietro»: con essa, Gesù non intendeva affatto mettere Pietro in una posizione di superiorità rispetto agli altri apostoli, né voleva dare il via ad una gerarchia ecclesiale. Su questo aspetto ho scritto abbondantemente alcuni giorni fa; si veda il seguente link per approfondire: http://www.solovangelo.it/2009/06/29/un-primato-di-paglia/
In effetti, l’assenza di tale frase nella narrazione di Marco (sapendo che essa arriva proprio dalle parole di Pietro), non è altro che un rafforzativo rispetto al fatto che Gesù non abbia nominato suoi vicari o successori: perfino il testo scritto sotto la supervisione di «Petrus» non fa menzione di primati particolari! Ma il Cascioli si dimostra così aggressivo nei confronti della chiesa di Roma, da prendere un passaggio che necessita di studio per essere compreso appieno, per voler compiere, attraverso di esso, un duplice attacco: al Vangelo di Marco in primis, e poi alla gerarchia cattolica, reale mira del lavoro dell’ex-sacerdote.
Continueremo nella prossima puntata con una analisi del Vangelo di Matteo: nel frattempo, invitiamo i nostri lettori ad esprimere i propri pareri in questo spazio.
 Proseguo in questo articolo, come promesso, l’analisi critica delle tesi di Luigi Cascioli in merito alla veridicità dei quattro Vangeli canonici, che l’ex-sacerdote afferma essere imposture. L’ultima volta abbiamo visto alcune note sul Vangelo di Marco, mentre in questa istanza ci occuperemo di quello di Matteo, il pubblicano che fu accolto al seguito di Cristo.
Proseguo in questo articolo, come promesso, l’analisi critica delle tesi di Luigi Cascioli in merito alla veridicità dei quattro Vangeli canonici, che l’ex-sacerdote afferma essere imposture. L’ultima volta abbiamo visto alcune note sul Vangelo di Marco, mentre in questa istanza ci occuperemo di quello di Matteo, il pubblicano che fu accolto al seguito di Cristo.
Seguirò la stessa linea adottata in precedenza, facendo quindi un piccolo cappello introduttivo al testo, per poi calarci nella confutazione delle asserzioni di Cascioli: prima di questo, comunque, vorrei spendere un po’ di tempo per fare un breve inciso sulla formazione del canone neotestamentario. Stando infatti a sentire Cascioli, sembrerebbe che esso sia venuto fuori dal nulla, complice una chiesa che ha messo insieme testi che sembrassero giustificare le proprie visioni. Pensandoci, poi, c’è addirittura una diceria secondo cui gli ecclesiali del tempo avrebbero sistemato gli scritti su uno scaffale, prendendo per buoni soltanto quelli che non caddero (non si sa se sospinti da forze spirituali, o per semplice legge di gravità).
Tralasciando l’ovvia ilarità che suscitano simili affermazioni, vediamo invece cosa abbia portato alla composizione del canone: F.F. Bruce, nel suo libro «The Canon of Scripture», identifica sei criteri principali attraverso i quali ebbe luogo il processo della canonizzazione. Essi sono i seguenti:
L’autorità apostolica L’antichità del testo L’ortodossia, ossia la linea dottrinale proposta dai testi La cattolicità, dal greco katholikos, ossia l’universale riconoscimento del testo L’uso tradizionale L’ispirazione Pietro Ciavarella, teologo e autore del libro «Risposta a Inchiesta su Gesù» si sofferma sui primi due, particolarmente utili alla sua trattazione; a riguardo di tali punti, egli afferma:
«Secondo il primo criterio, i libri ritenuti autorevoli dovevano essere stati scritti da uno dei primi seguaci di Cristo, o almeno essere associati con loro o comunicare il loro insegnamento (autorità apostolica). Il secondo criterio era collegato a questo ed era quello dell’antichità. Per essere canonico uno scritto doveva essere antico, doveva risalire il priù possibile ai tempi di Gesù. Questi due criteri illustrano sia la natura storica della fede cristiana sia la necessità avvertita dai primi cristiani di usare scritti che godevano di una vicinanza cronologica a Gesù. Il criterio dell’antichità, che rimane fondamentale tutt’oggi, è che i libri autorevoli devono risalire il più possibile al loro tema di fondo, Gesù. “L’antichità” è una premessa di fondo per l’attendibilità dei dati storici. Questo è anche il motivo per cui i Vangeli canonici coincidono con i vangeli più antichi pervenutici» (P.Ciavarella, Risposta a Inchiesta su Gesù, pp.23)
Da questi pochi punti vediamo, cioè, come la canonizzazione dei testi sacri sia stato un percorso di tipo analitico e scientifico, assolutamente lontano dalle accuse che le vengono mosse. Potremo approfondire questo discorso in altra sede, se i lettori lo riterranno. Per il momento, torniamo a concentrarci sul tema principale di questo articolo, ossia il Vangelo di Matteo.
L’autore
Dei quattro Vangeli, quello di «Matteo» è forse il più discusso, in termini di paternità. La maggioranza degli studiosi è incline a sposare senza troppi problemi l’antica tradizione che vorrebbe farlo risalire al discepolo di Gesù, quindi ad un testimone oculare degli eventi riportati nella narrazione. Il problema, a questo punto, è comprendere il motivo che avrebbe spinto Matteo ad utilizzare così tanto materiale di Marco (che, lo ricordiamo, è servito da base sia a Matteo che a Luca), un vangelo che non è stato scritto da qualcuno che avesse osservato personalmente Cristo. Tuttavia, non è necessario passare attraverso la precisa determinazione dell’autore del Vangelo per poterne comprendere gli insegnamenti; d’altra parte, il testo originale è anonimo.
Avendo comunque visto le brevi considerazioni sulla canonicità, possiamo tranquillamente appoggiarci al parere della chiesa primitiva, che vedeva appunto nel pubblicano Levi (poi Matteo) lo scrittore di quel vangelo così fortemente impregnato di ebraismo, nonchè di un acceso interesse per la legge veterotestamentaria.
La datazione
Esistono alcuni problemi sulla datazione del Vangelo di Matteo, e tali questioni trovano la loro origine in altre domande. Esso infatti deve essere stato redatto senza discussione dopo Marco, e dopo la raccolta di detti denominata «fonte Q». Questo ovviamente ci porterebbe ad una data sicuramente posteriore al 60 d.C., ma sulla base di questo solo punto, non possiamo determinare di quanto successiva.
Molti studiosi sono d’accordo nel datare questo testo dopo quello attribuito a Luca, in quanto contiene allusioni alla caduta di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C.. Come abbiamo già visto parlando di Marco, l’utilizzo dei brani predizionali per affermare una datazione posteriore a tali eventi è chiaramente un’asserzione forzosa, e la pretesa – da parte di alcuni – di una eventuale riscrittura della chiesa primitiva dei testi profetici alla luce di fatti successivi è già stata ampiamente additata come «ingenuo presupposto» dalla maggioranza degli esperti.
In ultimo, alcuni fanno notare che, data la minuzia della descrizione ecclesiastica osservabile in Matteo, esso debba essere fatto risalire alla fine del I secolo. Ad ogni modo, confrontando tale scritto con la lettera redatta da Paolo, all’indirizzo della chiesa di Corinto (55 d.C. circa), notiamo che non esistono grosse differenze. Le diverse risposte alle questioni presentate ci spingeranno quindi a datare il testo di Matteo in modi differenti: come la maggior parte degli studiosi, negli anni 80 d.C. – 100 d.C. o prima del 70 d.C., oppure addirittura nel ventennio 40 d.C. – 60 d.C. (come Robinson, Guthrie, e alcuni studiosi tedeschi).
La tesi, e la risposta
Veniamo ora a quanto il Cascioli scrive nelle sue brevi considerazioni sul Vangelo di Matteo, per vedere se esse siano attendibili, o se si rivelino l’ennesimo polverone volto al tentativo di destabilizzare le persone.
L’ex-sacerdote parte riportando la presentazione al Vangelo di Matteo presente sull’edizione CEI delle Sacre Scritture. Essa recita: «Scritto originariamente in Aramaico da Matteo, l’apostolo chiamato da Gesù al suo seguito distogliendolo dalla professione di esattore delle imposte, fu pubblicato tra il 40 e il 50». Stando a quello che abbiamo visto, questo inciso è da considerarsi pienamente pertinente alle trattazioni del mondo accademico: d’altra parte, sarebbe stupido asserire nozioni in aperto contrasto con quelle dell’intera comunità professionale.
Ma il Cascioli non demorde, e rilancia:
Cascioli: «La falsità della data attribuita dalla Chiesa al vangelo di Matteo ci viene incontestabilmente confermata da quel passo nel quale Gesù minaccia gli Ebrei di aver ucciso Zaccaria, figlio di Baracchia, che così recita: «..perché ricada su di voi (Ebrei) tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che avete ucciso tra il santuario e l’altare». (Mt. 23,35). Sapendo da Giuseppe Flavio che l’assassinio di questo Zaccaria avvenne nel 67, cos’altro si può dedurre, oltre a rimarcare l’ignoranza di coloro che fanno recitare a Gesù, morto nel 33, un fatto che non poteva assolutamente conoscere, che la data in cui fu scritto il vangelo di Matteo non è quella del 40-50 attribuitagli dalla Chiesa ma bensì posteriore all’anno 67? «Basterebbe soltanto questo riscontro storico per dimostrare che i vangeli, oltre che ad essere stati scritti molto tempo dopo l’epoca ad essi assegnata, furono compilati senza il rispetto delle verità storiche da autori che, pur di costruire la figura di Cristo, gli misero sulla bocca parole assurde senza dubitare che avrebbero tradito, in un’epoca di minore credulità, la loro impostura e le loro invenzioni». (E.Bossi. Gesù Cristo non è mai esistito- Ed. La Fiaccola. pag. 99).»
SoloVangelo: Dunque, Matteo dimostrerebbe di essere così stupido e superficiale, da riportare nel suo testo un avvenimento con il quale i suoi contemporanei avrebbero potuto sbugiardarlo? Sappiamo infatti che tale testo circolò per diverso tempo nel distretto di Antiochia di Siria, dopo la sua composizione. Se le cose fossero andate davvero in questo modo, la presunta falsità di datazione di questo Vangelo sarebbe stata provata ormai da secoli, senza aspettare che un ex-sacerdote in rotta con i suoi precedenti datori di lavoro coltivasse manìe da esegeta, spacciandosi per l’ennesimo nuovo latore di verità sconosciute.
Il personaggio di Zaccaria, nome logicamente molto comune al tempo di Gesù, non va confuso infatti con lo Zaccaria che fu ucciso nel Tempio durante la prima rivolta giudaica del 67 d.C., bensì si riferisce allo Zaccaria profeta dell’Antico Testamento; la storia ci parla dello Zaccaria citato da Giuseppe Flavio come del figlio di un certo Baruc, mentre è il profeta omonimo che dice, al primo versetto del testo che prende il suo nome di essere «Zaccaria, figlio di Barachia, figlio di Iddo, il profeta». Quindi il brano di Matteo 23:35 ci parla, rispettivamente, del primo «martire» dell’Antico Testamento (Abele) e dell’ultimo (Zaccaria). L’Antico Testamento non ci dà alcuna indicazione su come morì il profeta, tuttavia, possiamo osservare nel racconto di 2 Cronache 24:20-21 della morte di un altro Zaccaria, figlio di Ieoiada, il quale fu lapidato nel cortile del Tempio, in conformità quindi con la descrizione fatta da Gesù.
Vi è un solo manoscritto di Matteo che omette l’espressione «figlio di Barachia»: alcuni hanno pensato che lo Zaccaria del racconto di 2 Cronache fosse in realtà nipote di Ieoiada, e che il nome del padre fosse effettivamente Barachia. Ad ogni modo, vediamo come si tratti di un personaggio comunque veterotestamentario, martirizzato tra il Tempio e l’altare. Pertanto Gesù non solo ne era logicamente a conoscenza (facendo tali episodi parte della storia del suo popolo), ma voleva dare ad intendere come il periodo antico fosse effettivamente finito, e come da lì in avanti sarebbero cambiate le cose. Prendiamo quindi le parole del Bossi, rimasticate da Cascioli, per quello che sono: sproloqui senza fondamento, ricerche raffazzonate che vanno a scavare nella storia per trarne conclusioni assolutamente errate e faziose.
Cascioli: Dunque, dimostrato che la data attribuita dalla Chiesa è falsa, quando fu scritto in realtà il vangelo canonico di Matteo? Sapendo che gli fu attribuito intestato libricino databile, come abbiamo visto, tra il 135 e il 150 (vedi cap. precedente – Documenti della prima metà del II sec. “Pseudo vangeli di Marco e di Matteo”), ci verrebbe spontaneo di rispondere che fu scritto in questo periodo, se non considerassimo che Papia lo definì come una semplice raccolta di sentenze: «Matteo riunì in aramaico alcune sentenze del Signore che ciascuno le tradusse come poteva». Siccome il vangelo di Marco non può essere quello a cui si riferisce Papia perché è tutt’altro che una raccolta di sentenze ma una vera e propria biografia di Gesù, cos’altro si può dedurre se non che il canonico sia una riproduzione ampliata dello pseudo Marco e quindi posteriore al 150? Deduzione che ci viene confermata anche dal passo in esso contenuto che attribuisce a Pietro il primato sulla Chiesa che per quasi tutta la metà del secondo era stato invece riservato a Giacomo. «E ancora un’altra prova confermante la sua datazione posteriore al 150 ci viene dal passo “Tu es Petrus” che poteva essere stato scritto soltanto dopo che la Chiesa prese la decisione di togliere a Giacomo il primato sulla comunità di Gerusalemme, che tutti i documenti precedenti al 150 gli attribuivano, per passarlo a Pietro» (Guy Fau. pag.92).
SoloVangelo: Abbiamo visto come la pretesa di falsità della datazione sia infondata, e pertanto le successive asserzioni di Cascioli si trovano a cadere rovinosamente: nonostante questo, vediamo di discutere comunque quanto egli afferma, per non lasciare alcun interrogativo senza risposta. Matteo, in effetti, fu il redattore di altre versioni dell’omonimo Vangelo (anche se la datazione che ne da Cascioli è, come abbiamo visto, assolutamente errata), ma non si tratta di revisioni o pre-lavorazioni del definitivo, bensì di differenti rese linguistiche dello stesso testo: l’affermazione di Papia riportata dal Cascioli è la prova dell’esistenza di una versione di Matteo in aramaico, prima della stesura greca.
Il riferimento alla «raccolta di sentenze» merita due parole in più: Cascioli vorrebbe infatti che l’affermazione di Papia indicasse uno scritto redatto pressappoco come il Vangelo apocrifo di Tommaso, una raccolta di affermazioni senza una struttura narrativa. Nello scritto originale di Papia, vediamo che l’espressione «le sentenze del Signore» è resa con il termine «logia», che significa «oracoli», o «discorsi»: il Nuovo Testamento utilizza molto questo termine quando intende riferirsi agli oracoli comunicati al popolo per bocca dei profeti veterotestamentari, e Gesù era considerato dai suoi seguaci come un «profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo» (Luca 24:19).
Bruce afferma: «Isolando lo scritto che si trova alla base della «fonte Q» [menzionata sopra, ndR], ci si accorge come esso sia simile ai libri profetici dell’Antico Testamento. Tali scritti contengono normalmente la narrazione della chiamata del profeta al suo particolare ministero, con il resoconto dei suoi oracoli inseriti in una cornice narrativa» (F.F.Bruce, Possiamo fidarci del Nuovo Testamento, pag.50)
Quando Papia asserisce che ciascuno tradusse i detti del Signore come meglio poteva, sta implicitamente dichiarando come fossero in circolazione differenti rese greche di uno stesso testo, cosa che spiegherebbe alcune differenze tra i discorsi di Gesù riscontrabili in Matteo e Luca: in molte parti in cui il greco di questi vangeli differisce, è possibile dimostrare come la matrice aramaica sia però la stessa. Tutto ciò, comuque, ben prima del 150 d.C.: il rimaneggiamento dei testi ad opera di persone diverse dagli autori in epoche successive, è da escludersi.
Avendo poi dimostrato nel precedente articolo come datare Marco verso il 150 d.C. sia un’errore di proporzioni enormi, non ci soffermeremo su questo punto. Soltanto, commentiamo ancora l’affermazione secondo cui la chiesa primitiva tolse a Giacomo il primato sulla comunità di Gerusalemme. Forse chi asserisce questo ignora che Giacomo fu il primo apostolo ad essere ucciso, ma che fino a quel momento egli stesso, assieme a Pietro e Giovanni non svolgevano funzioni di «controllo» (in accezione negativa) sulla chiesa: erano senz’altro reputati importanti per la loro condizione (i tre appartenenvano infatti al “sottogruppo” di discepoli più vicini a Cristo), ma è importante notare come – subito dopo la formazione di assemblee cristiane nel mondo – essi rinunciarono a proporsi come «maestri della fede», ma, semplicemente, erano da considerarsi fratelli alla stregua di ogni altro credente sincero. Probabilmente, chi vuol vedere nella figura di Pietro un esempio di «tirannico controllore» lo fa perchè troppo scottato dalla figura di quell’uomo, vestito di bianco, che oggi pretende di rappresentare la norma alla quale adeguarsi. Grazie a Dio, però, la fede cristiana non equivale al moderno cattolicesimo!
Cascioli: E ancora: « Il “Tu es Petrus” non può essere stato aggiunto nel vangelo di Matteo che dopo il 180 dal momento che è ancora ignorato da Ireneo in questa data» (Las Vergnas- op. cit. pag.41). Dunque è chiaro che il vangelo canonico attribuito a Matteo, essendo un ampliamento del libricino che era stato scritto tra il 135 e il 150, è stato redatto nella seconda metà del II secolo da falsari che non potevano essere stati testimoni di un Gesù dichiarato morto nell’anno trentatré.
SoloVangelo: Rispondo che non è sulle supposizioni che si fonda uno studio serio. Il fatto che Ireneo non faccia riferimento a questa affermazione di Gesù non significa che essa non fosse già presente nello scritto di Matteo. Riflettiamoci – il fatto che ciascuno di noi, per tutta la vita, possa ignorare una determinata nozione relativa alla propria professione, fa di tale nozione qualcosa di inesistente? Chiaramente no, ogni uomo o donna ignora una marea di cose, anche in relazione al proprio campo di studio o lavoro. La mancata citazione, da parte di Ireneo, del «Tu sei Pietro» non è assolutamente un indizio serio: al più, può essere un segnale di non conoscenza, o di scarso valore assegnato al concetto. Ma non certo di inesistenza.
Sempre a riguardo poi del presupposto primato petrino, discusso ampiamente nel passato, riporto quanto ho scritto nella prima parte di questi studi:
Quest’osservazione nasce anzitutto da una cattiva comprensione della frase «tu sei Pietro»: con essa, Gesù non intendeva affatto mettere Pietro in una posizione di superiorità rispetto agli altri apostoli, né voleva dare il via ad una gerarchia ecclesiale. Su questo aspetto ho scritto abbondantemente alcuni giorni fa; si veda il seguente link per approfondire: http://www.solovangelo.it/2009/06/29/un-primato-di-paglia/
In effetti, l’assenza di tale frase nella narrazione di Marco (sapendo che essa arriva proprio dalle parole di Pietro), non è altro che un rafforzativo rispetto al fatto che Gesù non abbia nominato suoi vicari o successori: perfino il testo scritto sotto la supervisione di «Petrus» non fa menzione di primati particolari! Ma il Cascioli si dimostra così aggressivo nei confronti della chiesa di Roma, da prendere un passaggio che necessita di studio per essere compreso appieno, per voler compiere, attraverso di esso, un duplice attacco: al Vangelo di Marco in primis, e poi alla gerarchia cattolica, reale mira del lavoro dell’ex-sacerdote.
Spero vivamente che questa lettura sia stata proficua. Ricordo ai lettori la possibilità di approfondire la discussione attraverso i commenti; nella prossima “puntata”, tratteremo le tesi che Cascioli avanza nei confronti del Vangelo di Luca.
Dio vi benedica.
 In questa terza parte del nostro scritto, analizziamo la posizione dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito alla veridicità ed affidabilità del terzo vangelo canonico, ossia quello avente la firma di Luca, autore, tra l’altro degli Atti degli Apostoli. Come già fatto in precedenza, prima di passare alla confutazione delle argomentazioni del Cascioli, vediamo alcune informazioni relative al vangelo stesso, per poi calarci nella trattazione storico/biblica di quanto l’ex-sacerdote afferma, e dimostrare anche in questo caso come gli attacchi al Testo Sacro si rivelino consistenti come bolle di sapone, che non possono sussistere davanti ad una analisi seria.
In questa terza parte del nostro scritto, analizziamo la posizione dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito alla veridicità ed affidabilità del terzo vangelo canonico, ossia quello avente la firma di Luca, autore, tra l’altro degli Atti degli Apostoli. Come già fatto in precedenza, prima di passare alla confutazione delle argomentazioni del Cascioli, vediamo alcune informazioni relative al vangelo stesso, per poi calarci nella trattazione storico/biblica di quanto l’ex-sacerdote afferma, e dimostrare anche in questo caso come gli attacchi al Testo Sacro si rivelino consistenti come bolle di sapone, che non possono sussistere davanti ad una analisi seria.
L’autore
Agli inizi del II secolo, iniziano a prendere corpo le tradizioni che collegano il terzo Vangelo con una persona di nome Luca: il Canone Muratoriano, il prologo anti-marcionita a Luca, così come Ireneo, Clemente Alessandrino, Origene e Tertulliano, sono concordi nell’identificare Luca con l’autore di tale testo. Dal momento che tali tradizioni poggiano comunque su elementi che possono essere dedotti dal Nuovo Testamento, il loro valore è relativo: l’evidenza neotestamentaria è maggiormente utile nell’identificazione dell’autore di questo vangelo. In effetti, si tratta di un testo particolare, perchè incompleto: la narrazione che inizia nel vangelo prosegue poi, senza interruzioni, negli Atti degli Apostoli, libro con caratteristiche di stile e forma così simili a quelle del Vangelo da suggerire che essi siano entrambi stati scritti da una stessa mano. Entrambi i testi sono indirizzati ad una persona di nome Teofilo, quali testimonianza del ministero di Cristo, e successivamente della nascita e dello sviluppo della prima chiesa.
Nel libro degli Atti, possiamo notare diversi brani in cui l’autore intercambia il soggetto della narrazione da «essi» ed «egli» al pronome «noi», suggerendo quindi una sua compartecipazione agli eventi narrati, e pertanto il suo essere compagno dell’apostolo Paolo. Una accurata analisi dei racconti mostra come Luca sia appunto il redattore più probabile dei testi menzionati.
L’apostolo Paolo definisce questo Luca come medico. In effetti, alcune sue narrazioni sono maggiormente «tecniche» in tal senso: basti pensare al racconto della guarigione della donna affetta da emorragia. Luca è menzionato tre volte nel Nuovo Testamento come compagno di Paolo, e nella sua letera ai Colossesi, l’apostolo specifica che no nera un ebreo. Lo stile dei testi attribuiti al medico fa pensare che egli fosse di lingua greca. Secondo Eusebio, Luca proveniva da Antiochia, in Siria.
La datazione
Compito assolutamente arduo, quello di datare con certezza il terzo Vangelo: incorporando gran parte del materiale edito da Marco, è logico pensare che esso sia stato redatto quando il lavoro di Marco era già terminato, ed era quindi in circolazione. Alcuni asseriscono che Luca doveva essere a conoscenza della distruzione di Gerusalemme, cosa che indicherebbe una scrittura posteriore al 70 d.C.; altri studiosi, invece, non accettando questa teoria assegnano al Vangelo una data anteriore, intorno agli anni 57-60 d.C.
La tesi, e la risposta
Veniamo ora alle tesi del Cascioli, ed alle risposte che riteniamo di fornire alle sue accuse. Come abbiamo visto nei precedenti articoli, relativamente ai Vangeli di Marco e Matteo, l’ex-sacerdote inizia la sua arringa citando la prefazione al Vangelo tratta dall’edizione C.E.I.: anche in questo caso egli ripropone lo stesso schema, per saltare subito alle sue conclusioni. Vediamolo nel dettaglio:
Cascioli: Presentazione della Chiesa: «Luca, autore anche degli Atti degli Apostoli, fu un colto medico siriano convertitosi in Antiochia verso l’anno 43. Conobbe Cristo dai primi testimoni della sua vita e si preparò con accurata indagine. Luca svolge il suo lavoro su un materiale proveniente da ambiente palestinese, non escluso il contributo della stessa Madre di Gesù. Fu scritto fra il 65 e il 70». L’attribuzione a Luca, apostolo vissuto nella Comunità di Gerusalemme insieme a Pietro, Giacomo, gli apostoli e la Madonna, non può essere che fantastica. Dal momento che questo vangelo fu scritto per confutare i concetti gnostici del vangelo di Marcione, di conseguenza non può essere anteriore al 144. Per quanto la Chiesa cerchi, invocando l’autorità di Tertulliano, di dimostrare che fu Marcione ad imitare Luca, le prove che dimostrano che invece furono i redattori di Luca a ricopiare Marcione sono state ampiamente portate da Couchoud nel suo “Primi Scritti del Cristanesimo”.
SoloVangelo: La prefazione C.E.I. conferma quanto abbiamo visto in apertura: essa indica in Luca un medico siro, datando il suo lavoro in un lasso di tempo che tutto sommato concorda con quanto abbiamo discusso. Ma il Cascioli non ci sta, e parte al contrattacco, spiegando come l’intento di Luca fosse dichiaratamente anti-marcionita e, pertanto, esso debba essere fatto risalire ad una data posteriore al 144 d.C.. Se avesse letto il Vangelo che pretende di commentare, Cascioli avrebbe scoperto però che per stessa affermazione dello scritto, il proposito originale era quello di rendere il destinatario del lavoro, il Teofilo citato poco sopra, «certo delle cose che gli sono state insegnate». È evidente quindi che Teofilo fosse un cristiano, e che Luca scrisse per aiutare lui (e presumibilmente altri) a comprendere meglio gli aspetti della fede cristiana. L’intento di Luca, per sua stessa ammissione, era quello di fare un dettagliato resoconto storico, perchè il messaggio che egli voleva esporre, per poter avere un peso reale, doveva essere fortemente ancorato alla realtà dei fatti. Non esiste un testo neotestamentario più calzante di Luca nel descrivere Gesù quale amico e Salvatore degli uomini, e questo era il proposito del medico: la chiesa del suo tempo aveva necessità di comprendere che la sua missione nel mondo era fondata sull’insegnamento e sull’esempio del Cristo. Rifiutiamo pertanto la tesi del Cascioli, che come sempre intende vedere cospirazioni laddove esse non hanno motivo di esistere.
Piccola nota: facciamo presente che, contrariamente a quanto affermato dal Cascioli, Luca non è mai stato annoverato nella cerchia degli apostoli, ma era compagno di viaggio di uno di essi, ossia Paolo. Può sembrare una nota leziosa, inutile, ma riteniamo che quando si ha la pretesa di proporsi come una valida fonte di informazione per terze persone, si debba avere cura anche dei particolari, cosa che l’ex-sacerdote certo non dimostra.
Cascioli: a) Noi sappiamo che il vangelo di Marcione è conosciuto nel 140 da Papia mentre quello di Luca è ignorato dallo stesso Papia nel 150. b) Il vangelo di Marcione era molto più corto di quello di Luca, e in questi casi non si accorcia mai, ma piuttosto si allunga. c) Numerosi passi di Luca hanno un evidente carattere anti-marcioniano. d) Per analogie di espressioni e uguaglianza di stile, tutto porta a credere che il vangelo attribuito a Luca sia stato scritto, almeno nella sua prima stesura, da Clemente, autore di una lettera ai Corinti, che è vissuto a Roma negli anni 155-165”. (Couchoud. Primi Scritti del Cristianesimo- Pgg. da 7 a 31).
SoloVangelo: In merito al punto a), riteniamo sia quantomeno risibile il commento: abbiamo già precedentemente discusso di come la mancata citazione di uno scritto non equivalga né ad ignorarlo, e nemmeno sia evidenza della sua inesistenza, pertanto ci pare che il silenzio di Papia sul terzo Vangelo non sia affatto prova di una sua stesura successiva. I succesivi due punti, b) e c), si basano sul presupposto che Luca volesse contrastare l’insegnamento marcionita: abbiamo già indicato come questa finalità non corrisponda affatto a quella reale dell’evangelista. Inoltre, essendo senz’ombra di dubbio vissuto antecedentemente allo stesso Marcione, ci pare assurdo asserire che nei propositi di Luca fosse presente il contrasto ad un’eresia che non era ancora formata mentre egli scriveva. Tra l’altro, vedremo tra poco che Marcione stesso introdusse proprio il Vangelo di Luca nel suo canone. Il punto d) presenta invece un problema di esclusione logica: se, come è vero, il Vangelo di Luca ed il libro degli Atti sono attribuiti allo stesso autore per continuità narrativa ed uguaglianza stilistica (e tali testi siano risalenti senz’altro al periodo di intorno alla caduta di Gerusalemme), riteniamo azzardato tracciare un parallelo con testi di circa 80 anni più recenti rispetto a quelli analizzati.
Questo punto ci offre comunque la possibilità di discutere la preparazione di coloro che vogliono affossare la veridicità dei Vangeli: come si è potuto leggere, costoro parlano di Clemente, autore di una lettera ai Corinti (quindi, stiamo parlando di Clemente Romano), come di un personaggio vissuto tra il 155 ed il 165 d.C.. Curioso, però, che fonti storiche comprovate (quali Eusebio di Cesarea e Girolamo) ci fanno sapere della sua morte, avvenuta nel 101 d.C.. Che dire dunque, di sedicenti esperti che si propongono quali «fari nella notte dell’ignoranza», e sono essi stessi ignoranti? Per usare le parole del Signore: «Medico, cura te stesso!».
Cascioli: Il fatto poi che, da quanto è stato dimostrato da Marcello Craveri, almeno per il 90 per cento ricopia le sentenze dei vangeli gnostici e i vari papiri datati agli anni 130-135, non è un’altra inconfutabile dimostrazione che la data attribuitagli dalla Chiesa è indiscutibilmente falsa?
SoloVangelo: Noi diremmo di no, dal momento che il lavoro di Luca trova la sua base ispiratrice – come già sottolineato – in Marco, quindi in un testo assolutamente non gnostico, e per giunta redatto ben precedentemente alle date proposte. Sottolineiamo inoltre come la datazione dei vari testi sacri non sia stata data loro dalla chiesa romana, bensì sia il risultato di varie tradizioni, delle quali si è poi cercata (e trovata) conferma scientifica: quelle che oggi esponiamo come date praticamente sicure, non sono campate in aria da religiosi, ma ricercate e comprovate da esperti nel campo del riscontro cronologico.
Cascioli: Che il vangelo di Luca sia il risultato di continue sovrapposizioni che si sono susseguite per tutto il II secolo e oltre ci viene da Tatiano che nel suo Diatesserone, scritto nel 175, (libro che riuniva in un solo testo i quattro vangeli canonici), non riporta quella nascita di Gesù che fu appunto aggiunta, come nel vangelo di Matteo, soltanto tra la fine de II secolo e gl’inizi del III, cioè quando la Comunità di Roma, in seguito alle critiche degli oppositori che gli facevano rimarcare come potesse Gesù essersi incarnato se non aveva una nascita terrena, decise di farlo partorire da una donna, una donna vergine come veniva sostenuto per le divinità pagane nel Culto dei Misteri.
SoloVangelo: Taziano (e non Tatiano come scrive il Cascioli) fu un cristiano siriaco che ebbe l’idea di redigere un testo il quale presentasse le narrazioni dei quattro Vangeli canonici utilizzando una soluzione di continuità: si tratta di un’opera unica, perchè tenta di combinare linearmente gli scritti evangelici: non per nulla è anche chiamato, a volte, col nome di “Armonia dei Vangeli”. Oggi non ne esiste alcuna copia, in quanto si tratta di un lavoro andato interamente distrutto per ordine del vescovo Teodoreto (423 d.C.), il quale volle, per la chiesa siriaca, l’adozione dei vangeli in forma separata, così come era d’uso nelle altre chiese cristiane. Ciò che sappiamo oggi del Diatessaron sono nozioni indirette, che ci arrivano dal commentario redatto da Efrem il Siro, dottore della chiesa. Ad ogni modo, è appena logico che la narrazione dell’Armonia fosse una sorta di «summa concisa» dei quattro Vangeli, pertanto probabilmente mancante di parti di essi, in favore di altri scorci. Insomma, la critica verso l’episodio della nascita di Cristo non sta assolutamente in piedi.
Altra bufala storica è poi accusare la chiesa romana di aver introdotto la nascita verginale di Cristo come adattamento ai culti misterici pagani, quando abbiamo testimonianze di come la prima cristianità fosse ben a conoscenza di un tale dato. Inoltre (ma in questo caso si deve aver fiducia nel Testo Sacro quale Parola di Dio) notiamo la presenza di profezie veterotestamentarie sulla nascita del Messia, che fanno appunto riferimento alla verginità della madre.
Cascioli: Un’altra prova dimostrante che la Nascita di Gesù fu aggiunta nei vangeli di Luca e di Matteo in epoca tardiva ci viene da Marcione per il fatto che di essa non fa alcuna menzione nella sua “Edizione Evangelica” che scrisse intorno al 170 per confutare i quattro vangeli.
SoloVangelo: Abbiamo già discusso molte volte di come una mancata citazione non sia indizio di inesistenza. Ad ogni modo, riteniamo sia necessario soffermarsi brevemente sulla persona di Marcione, per toccare con mano quanto le tesi di Cascioli siano campate in aria. Marcione era un filosofo cristiano, le cui idee sarebbero poi state in seguito bollate di eresia. Durante una sua visita a Roma, egli elargì una cospicua donazione alla chiesa romana, ottenendone i favori e guadagnando di potersi fermare per ben cinque anni nella città ad insegnare la propria visione della fede cristiana. Scrisse in effetti molto, ma il suo lavoro più importante non uscì dalla sua penna, essendo un testo di cui curò l’edizione: stiamo parlando della «edizione evangelica» citata dal Cascioli. Tale «edizione» non aveva affatto lo scopo di confutare i Vangeli canonici, bensì era una rielaborazione dei testi ritenuti autorevoli sotto il profilo dottrinale, per adattarli alle tesi marcionite. Il canone di Marcione conteneva un solo vangelo (quello di Luca, per l’appunto), e dieci epistole. Tutto qui: Marcione era convinto che il Dio dell’Antico Testamento e quello del Nuovo fossero due entità separate, e che Gesù fosse stato inviato dal Dio neotestamentario, un Dio buono, per salvare l’umanità dall’ira del Dio degli Ebrei. Senza scendere troppo in dettaglio nel pensiero marcionita (cosa che richiederebbe molto tempo, e che ci farebbe finire fuori tema), sottolineiamo comunque come i testi inclusi dal filosofo nel suo canone abbiano subìto una sorta di «adattamento editoriale», ossia modifiche nei punti che sarebbero entrati in contrasto con quanto Marcione stesso si era proposto di insegnare.
Per questo motivo, l’assenza della nascita e genealogia di Gesù nel testo adattato da Marcione non deve stupirci: come possiamo constatare leggendo il Vangelo di Luca, Gesù viene messo in diretto collegamento con il Dio veterotestamentario, proprio citando a ritroso i suoi antenati, fino a giungere ad Adamo, ed a Dio stesso, quale principio e radice della discendenza del Cristo. È chiaro come un brano del genere potesse mettere in grande crisi le tesi marcionite, e l’eliminazione di questa parte del testo dovette sembrare una «soluzione accettabile». Paradossalmente, considerando il pensiero di Marcione, potremmo dire che è proprio l’assenza di una tale narrazione a confermarne la reale esistenza!
Cascioli: D’altronde per comprendere quanto la nascita terrena di Gesù sia il prodotto di falsificazioni, basta rimarcare la discordanza che c’è tra quella raccontata nel vangelo di Matteo e quella riportata sul vangelo di Luca la cui veridicità di quest’ultimo viene garantita dalla Chiesa dicendo che fu la stessa madre di Cristo a raccontargliela.
SoloVangelo: Preferiamo tacere su fantasiose tradizioni, che hanno da sempre contribuito a fare apparire la fede come qualcosa di impalpabile, fondato sul nulla. Abbiamo prove storiche e critiche: che le invenzioni umane tacciano davanti ad esse!
Cascioli: Comunque una cosa è certa: la qualifica di medico che viene data a Luca dalla Chiesa e la serietà che allo stesso viene conferita nella stesura del vangelo, risultano quanto mai discutibili dalla seguente semplice analisi dei seguenti passi:
1) «Al tempo di re Erode, re della Giudea, il Signore rese grazia al sacerdote Zaccaria rendendo fertile Elisabetta sua moglie, già avanzata nell’età. Da essa nacque un figlio che chiamarono Giovanni. (Lc.1-5).
2) Sei mesi dopo, lo stesso angelo che aveva annunciato a Zaccaria di essere diventato padre, si presenta a Maria e le comunica di essere incinta dello Spirito Santo. (Lc. 1-26).
3) Dopo sei mesi dalla nascita di Giovanni, Maria, moglie di Giuseppe, partorì Gesù a Betlemme dove era andata per via del censimento ordinato da Quirinio, Governatore della Siria». (Lc. 2-1).
Basta fare un semplice calcolo tra la data del concepimento e la data del parto, per renderci conto come il redattore del terzo vangelo, oltre a non aver eseguito “accurate indagini”, non era certamente neppure un medico. Sapendo che Erode, re di Giudea è morto nell’anno – 4 e che il censimento c’è stato negli anni +6 e +7, cosa esce fuori? Esce fuori che la Madonna ha avuto una gravidanza, come minimo, di undici anni. …e ancora una volta Catilina abusa della nostra pazienza!
Finita la risata, voglio aggiungere che questa è una prova determinante per dimostrare che chi ha scritto il terzo vangelo non è stato un dotto medico siriano che ha riportato fatti veramente accaduti mentre lui era in Palestina, ma bensì un somaro pagano che s’inventò come poté tutta una storia per giustificare, attraverso una nascita terrena, l’incarnazione di Cristo.
SoloVangelo: Vediamo ora se il titolo di «somaro pagano» sia davvero da riferirsi al terzo evangelista, oppure se non sia una proiezione che sarebbe meglio affibbiare ai suoi detrattori.
Cito alcune informazioni dall’ottimo commentario di John MacArthur:
Publio Sulpicio Quirino è noto per aver governato la Siria negli anni dal 6 al 9 d.C. Un noto censimento ebbe luogo in Israele nel 6 d.C. Giuseppe Flavio racconta che tale misura provocò una violenta rivolta giudaica (menzionata da Luca, che cita Gamaliele, in Atti 5:37). Quirinio era responsabile dell’organizzazione del censimento e ricoprì anche un ruolo fondamentale nella repressione della successiva rivolta. Comunque, tale censimento ebbe luogo circa un decennio dopo la morte di Erode ed è troppo tardivo per collimare con la cronologia di Luca. Alla luce della meticolosa accuratezza dell’evangelista come storico, sarebbe irragionevole accusarlo di un anacronismo così palese, cosa che invece il Cascioli sembra voler fare. L’archeologia ha infatti res giustizia a Luca: un frammento di pietra scoperto a Tivoli nel 1764 d.C. contiene un’iscrizione in onore di un ufficiale romano che, si legge, fu due volte governatore della Siria e della Fenicia durante il regno di Augusto. Il nome dell’ufficiale non è presente sul frammento, ma fra le sue imprese sono citati dettagli che, per quanto ci è dato di conoscere, non possono riferirsi ad altri che a Quirinio.
Dunque, questi deve essere stato governatore della Siria due volte. Egli fu probabilmente governatore militare all’epoca in cui Varo era, storicamente, governatore civile in quella regione. Per quanto riguarda la datazione del censimento, alcuni antichi documenti trovati in Egitto menzionano un censimento mondiale ordinato nell’8 a.C. Nemmeno questa datazione è immune da problemi. Gli studiosi sono generalmente concordi nel situare la nascita di Cristo attorno al 6 a.C. al più presto. Evidentemente il censimento fu ordinato da Cesare Augusto nell’8 a.C., ma non ebbe in realtà luogo in Israele se non due o quattro anni più tardi, forse a causa delle difficoltà politiche esistenti fra Roma ed Erode. Pertanto non possiamo determinare con certezza l’anno della nascita di Cristo, ma possiamo affermare che non fu probabilmente prima del 6 a.C. né certamente dopo il 4 a.C. I lettori di Luca, avendo familiarità con la storia politica di quel periodo, sarebbero stati in grado senza troppe difficoltà di individuare una data precisa sulla base delle informazioni fornite da Luca.
Luca fu quindi uno storico di prim’ordine, che volle realmente dare la possibilità ai suoi lettori di conoscere il Cristo, mostrando loro come si trattasse di un personaggio reale, al quale ci si poteva riferire in termini di coordinate storiche. Quelle stessa coordinate che, secondo il pensiero scritturale, rappresentarono la perfetta pienezza dei tempi, nella quale Gesù Cristo, quale Dio incarnato, volle caricare su di sé i nostri peccati, per dare a ciascuno la possibilità della riconciliazione con Dio, attraverso la fede nel suo sacrificio espiatorio.
Ancora una volta, spero che le informazioni che abbiamo voluto trattare siano risultate interessanti per i nostri lettori. Invitandovi, come sempre, ad esprimere i vostri commenti, vi rimandiamo alla prossima puntata, in cui tratteremo le accuse mosse contro il quarto Vangelo, ossia quello attribuito all’apostolo Giovanni, il discepolo che Gesù amava.
 In questo quarto ed ultimo articolo, dedicato alla confutazione delle tesi dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito ai Vangeli canonici, abbiamo deciso di adottare uno stile leggermente differente rispetto ai tre articoli precedenti: mentre nel caso dei tre sinottici abbiamo prima presentato una sorta di “scheda riepilogativa” di ciascun Vangelo, contenente alcune informazioni sui vari testi, e solo in seguito ci siamo calati nella critica delle accuse, questa volta affronteremo direttamente la confutazione di quanto proposto dal Cascioli, fornendo mano a mano le nozioni utili a comprendere quanto trattato.
In questo quarto ed ultimo articolo, dedicato alla confutazione delle tesi dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito ai Vangeli canonici, abbiamo deciso di adottare uno stile leggermente differente rispetto ai tre articoli precedenti: mentre nel caso dei tre sinottici abbiamo prima presentato una sorta di “scheda riepilogativa” di ciascun Vangelo, contenente alcune informazioni sui vari testi, e solo in seguito ci siamo calati nella critica delle accuse, questa volta affronteremo direttamente la confutazione di quanto proposto dal Cascioli, fornendo mano a mano le nozioni utili a comprendere quanto trattato.
Ci auguriamo che quanto andiamo ad esporre possa rappresentare, assieme a quanto già detto in passato, un’utile fonte alla quale attingere per rendersi conto della debolezza di certe tesi, che vorrebbero affondare la storicità della Parola di Dio.
La tesi, e la risposta
Cascioli: Presentazione della Chiesa: «L’antica tradizione ecclesiastica afferma che il IV vangelo fu scritto dall’apostolo Giovanni, il prediletto di Cristo, quando aveva raggiunto l’estrema vecchiezza nella comunità cristiana di Efeso, metropoli dell’Asia Minore. Il vangelo fu scritto verso l’anno 100 e il più antico manoscritto che lo tramanda è del 150, al massimo del 200». (Dalla Sacra Bibbia – Ed. C.E.I.). Anche se basterebbe considerare che questo vangelo è uscito dopo gli altri tre, posteriori tutti al 150, per dimostrare che la data del vangelo di Giovanni non è l’anno 100 ma bensì l’anno 200 che la Chiesa gli dà come manoscritto riproducente la versione originale.
SoloVangelo: Come abbiamo già dimostrato nei precedenti articoli, ai quali rimandiamo per maggiori dettagli, i tre Vangeli sinottici sono stati redatti ben prima delle datazioni proposte dal Cascioli, e anche ipotizzando una scrittura tardiva del quarto Vangelo, non raggiungeremmo comunque l’anno 200. Sottolineiamo inoltre come sia necessario qualche dato in più per posizionare cronologicamente un manoscritto, che il semplice confronto con fonti più o meno parallele. Vedremo a breve come il problema della datazione di Giovanni sia più complesso di ciò che si vuole far credere nelle accuse, e potremo inoltre notare come il raggio entro cui circoscriverlo sia più ristretto e preciso di quanto appaia nelle premesse dell’edizione C.E.I. e del Cascioli.
Cascioli: «La data attribuita all’anno 100 al quarto vangelo è in realtà molto più tardiva se consideriamo che nessuno prima di Ireneo parla di esso verso il 190. Lo ignorano Marcione, Giustino (autore di due apologie sul cristianesimo, morto nel 165), Papia che viveva ad Efeso nello stesso periodo nel quale Giovanni avrebbe scritto il vangelo non ne fa menzione e lo ignora persino Policarpo che, secondo la Chiesa, era discepolo dello stesso Giovanni.». (Las Vergnas. op. cit.. pag. 37). E ancora: «L’attribuzione di questo vangelo a un discepolo di Gesù è di per se già sufficiente a rendere inaccettabile l’autenticità dell’autore per i suoi contenuti filosofici e teologici: cosa ne poteva sapere un ignorante pescatore della Galilea della dottrina neo-platonica del Logos? Il Vangelo è citato per la prima volta da Ireneo nel 190. Esso deve essere di poco anteriore a questa data poiché, oltre a considerare già compiuta la separazione tra i cristiani e i giudei, esprime la fusione del Cristo incarnato con il Logos di Filone e degli gnostici che si realizzò soltanto nella seconda metà del II secolo. Il valore storico dell’opera è quindi nullo. Ma esso lo è ancora di più per la discordanza su numerosi fatti riportati sugli altri tre vangeli. Infine, altra prova determinante per stabilire la sua tardività è il suo anacronismo determinato dai numerosi inni liturgici che riporta i quali dimostrano l’esistenza di un’organizzazione di culto già in atto.» (Guy Fau. op.citata. pag. 94).
SoloVangelo: Ancora una volta facciamo notare, come già fatto in precedenza, come la mancanza di citazione non debba per forza tradursi in “inesistenza”. Ad ogni modo, le prove esterne che vengono citate dal Cascioli contro questo Vangelo sono assolutamente inesatte. F.F.Bruce, nel suo testo “Possiamo fidarci del Nuovo Testamento?”, riporta a questo proposito le seguenti considerazioni: «Abbiamo già citato la testimonianza del papiro che attesta una data precoce. Ignazio, il cui martirio ebbe luogo all’incirca nel 115 d.C., fu influenzato dall’insegnamento particolare di questo Vangelo; Policarpo, scrivendo alla chiesa dei Filippesi poco dopo il martirio di Ignazio, cita la prima Epistola di Giovanni la quale, secondo l’opinione di Lighfoot, Westcott e altri, era unita al Vangelo come lettera di accompagnamento, o comunque era strettamente collegata a esso. Lo gnostico Basilide (130 d.C. ca.) cita Giovanni 1:9 come “nei Vangeli”. Giustino Martire (150 d.C. ca.) cita dal racconto di Nicodemo in Giovanni 3. Il suo discepolo Taziano (170 d.C. ca.) include il quarto Vangelo nel suo Diatessaron [o Armonia dei Vangeli: ne abbiamo discusso in un precedente articolo, NdR]. Più o meno nello stesso periodo Melitone, vescovo di Sardi, mostra nelle sue Omelie pasquali una qualche dipendenza da questo Vangelo.
Per quanto concerne poi la figura di Papia, facciamo notare che egli stesso ci fornisce, nella sua “Esegesi dei detti del Signore” (130-140 d.C. ca.), una testimonianza piuttosto forte della paternità giovannea del testo, dal momento che sostiene di aver redatto una copia di questo Vangelo sotto dettatura di Giovanni l’anziano, quest’ultimo discepolo dell’omonimo apostolo. Altro che testo sconosciuto! Ci rammarica vedere come coloro che intendono screditare le Sacre Scritture siano pronti a torcere perfino la realtà storica, pur di piegarla ai loro propositi.
Ancora, relativamente alla questione del concetto di “Logos”, vediamo come nel II secolo l’unica voce dissenziente sembra provenire da persone che non gradivano la presentazione di una tale dottrina nel prologo, negando quindi la redazione apostolica per ascriverla ad un certo Cerinto, eretico famoso vissuto alla fine del I secolo. Epifanio chiama queste persone alogoi, non soltanto per indicare che essi avevano rifiutato la dottrina del Logos, ma anche per descriverli come personaggi privi di logos, ossia di ragione. L’unica persona rilevante ad essi collegata pare fosse un certo Gaio di Roma (200 d.C. ca.), un ecclesiastico ortodosso eccetto che per il rifiuto del quarto Vangelo e dell’Apocalisse. Accantonando tali personaggi, il Vangelo è stato generalmente accettato nel II secolo sia da ortodossi che eretici.
Cascioli: E ancora più interessanti, se possiamo dire questo, sono le osservazioni di Turmel tra le quali viene confutato quel documento di “Reyland” databile al 130 che, riportando il nome di Giovanni, la Chiesa porta come prova per dimostrare che il IV vangelo fosse già esistente in questa data. «Un’analisi approfondita sul vangelo di Giovanni ci permette di distinguere in esso tre stratificazioni integrative successive. a) Un racconto aneddotico della vita di Gesù, che sarebbe più vecchio di tutto il resto, possiamo trovarla nello pseudo-Giovanni dal quale viene tratto il vangelo canonico di Giovanni. Nello pseudo Giovanni infatti vengono riportati degli aneddoti sulla vita di Cristo scritti da un certo Giovanni detto il Presbitero, morto a Efeso, nel 135, il quale però non ha nulla a che vedere con il Giovanni discepolo di Gesù. Tutto fa pensare che la Chiesa si sia servita di questo Giovanni detto il Presbitero per costruire la figura di Giovanni l’evangelista» (Turmel. Il Vangelo di Giovanni. Bolletino del Circolo Rnan, Gennaio del 1962).
SoloVangelo: Ancora una volta, le fonti di Cascioli pongono un manoscritto ad una datazione eccessivamente tardiva rispetto alla sua reale cronologia. In merito al papiro Rylands (o p52), lasciamo la parola alle ottime osservazioni di Vittorio Messori, nel suo libro “Ipotesi su Gesù”, Sei, Torino 1979, p. 175-176:
Nel 1935 (poco dopo, cioè, il libro del Couchoud che volgarizzava la tesi mitica) l’inglese Roberts pubblicava un papiro, il P. 52 o Rylands greco, scoperto tra le sabbie del Medio Egitto. Un semplice frammento ma di importanza decisiva: si tratta di 114 lettere greche del vangelo di Giovanni. È fuori discussione che sono state scritte non più tardi dell’anno 125. Ora, il vangelo di Giovanni è per ammissione unanime l’ultimo in senso cronologico.
Caposaldo dei mitologi (ma anche di molti critici) era che quel testo fosse stato scritto dopo il 150 sino al 200. Soltanto con questa datazione si poteva sperare di avere il tempo necessario per il precisarsi del mito. Il papiro Rylands greco ha tolto quella possibilità. Si è pure dimostrato infatti che il frammento trovato in Egitto è la copia di un originale scritto ad Efeso: quindi già attorno al 100 il più tardo dei vangeli aveva la sua forma definitiva. Mentre Gesù, per i mitologi sarebbe stato inventato «dopo» il 100… (6)
6) A proposito di papiri e, in generale, di testi arcaici del Nuovo Testamento notiamo che, a giudizio unanime degli specialisti, “nessun libro dell’antichità è stato trasmesso con tanta accuratezza, abbondanza e antichità di manoscritti come il Nuovo Testamento” (Thiel). Sono conosciuti attualmente ben 4.680 antichi testi neotestamentari, tra cui una settantina di papiri. Al di là dei frammenti (pur di importanza decisiva, primo tra tutti il P. 52) nel 1956 è stato pubblicato il P 66: contiene per intero proprio il vangelo di Giovanni. La datazione è all’anno 150. Gran parte del Nuovo Testamento è nel P. 45, ritrovato tra le sabbie d’Egitto nel 1930: è anteriore all’anno 200.
Per capire con quale inaudita autorità testuale si presenti il Nuovo Testamento, occorre osservare che per gli scrittori greci il tempo che intercorre tra l’originale e il primo manoscritto in nostro possesso è di almeno milleduecento anni. Per Eschilo (vissuto tra il 525 e il 456 a.C.) il primo manoscritto di una sua tragedia è del secolo XI d.C. Tra stesura e copia un intervallo di qualcosa come 1.500 anni!
Malgrado questa situazione, lo studio critico degli autori classici non ha mai pensato di negare in blocco l’autenticità dei testi o addirittura l’esistenza storica dell’autore. Il sospetto, la negazione, il rifiuto sembrano da certa critica riservati solo a Gesù di Nazareth. Ecco infatti il Donini che senza procedere a confronti con la situazione degli altri testi antichi, tanto per mantenere viva nel lettore la sfiducia nella storicità dei vangeli, scrive che questi “sono giunti a noi in una tradizione manoscritta assai tarda” e che “i più antichi risalgono a notevole distanza dalla redazione primitiva”. Ci si chiede che cosa si dovrebbe dire dello studioso, ad esempio, di Platone che lavora su manoscritti separati da 13 secoli dall’originale.
Per quanto invece concerne l’accenno al cosiddetto “pseudo-Giovanni”, va detto che, rimuovendo dal Vangelo il prologo, il testo prende una forma decisamente ebraica, attenuata appunto dal prologo, che trasforma il Vangelo in un libro maggiormente adatto ad un’utenza greca. È del tutto possibile che l’incipit del testo sia stato aggiunto in un secondo tempo, probabilmente dopo il completamento del lavoro originale. Vediamo inoltre come il passaggio “anomalo” tra il capitolo 20 ed il 21 facciano anch’essi pensare ad un’aggiunta posteriore, anche se lo stile ed il linguaggio sono così vicini a quelli del resto del Vangelo da far ipotizzare che essi siano stati compilati dallo stesso autore del testo. Appare possibile – secondo John Drane – che il Vangelo sia stato scritto prima in Palestina, per dimostrare che «Gesù è il Cristo». L’autore forse si rivolgeva agli ebrei settari influenzati da idee come quelle di Qumran. Poi, quando si vide che lo stesso insegnamento era valido per gente di altre parti dell’impero romano, il Vangelo fu riveduto: furono spiegati gli usi e le espressioni ebraiche e furono aggiunti il prologo e l’epilogo. Alcune parole del capitolo 21 fanno pensare che la stesura finale del Vangelo possa essere stata diretta a una comunità giudeo-cristiana del mondo ellenistico, forse a Efeso.
Cascioli: b) Il prologo comportante l’identificazione del Cristo con il Logos di Filone che non era stata ancora realizzata dal nuovo cristianesimo prima del 165 come dimostra Giustino che la disconosce nelle sue due “Apologie sul Cristianesimo” scritte appunto in questa data. c) Numerose interpolazioni romane che falsano il senso di alcuni passaggi. Da notare infine che secondo il “Canone di Muratori”, (datato all’anno 200), risulta il IV vangelo essere un’opera collettiva redatta da una equipe di discepoli ispirati che si sono messi d’accordo per mettere tutto sotto il nome di Giovanni. Il vangelo di Giovanni è poi così impastato di concetti tratti dalla gnosi da ritenere assurda ogni pretesa che lo ponga precedente agli anni 150-160.
SoloVangelo: Se abbiamo già discusso poco sopra la questione legata al “Logos”, notando come in realtà si trattasse di un aspetto largamente accettato, intendiamo spendere alcune parole in più sul Canone Muratori: ancora una volta, infatti, il Cascioli propone citazioni da testi che in realtà affermano proprio il contrario di quanto egli vorrebbe. Osserviamo infatti un piccolo scorcio di tale documento, notando come esso indichi proprio nell’apostolo Giovanni l’autore del quarto Vangelo:
«Il quarto degli evangeli (è quello) di Giovanni, (uno) dei discepoli. Poiché i suoi discepoli e vescovi lo esortavano, disse: «Digiunate con me per tre giorni da oggi e ci racconteremo a vicenda ciò che ad ognuno verrà rivelato». In quella stessa notte fu rivelato ad Andrea, (uno) degli apostoli, che Giovanni doveva mettere tutto per iscritto in nome proprio, mentre tutti (lo) avrebbero esaminato»
Ecco che diventa istantaneamente chiara l’asserzione evangelica in Giovanni 21:24, la quale recita: «e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera». Lo scritto di Giovanni fu cioè esaminato con cura, ricevendo poi il benestare di coloro che avevano il compito di controllare nel dettaglio la correttezza della narrazione. Abbiamo inoltre un altro documento, ancora più importante in tal senso, ossia il prologo antimarcionita a Giovanni, che ci fa sapere quanto segue:
«Il Vangelo di Giovanni fu redatto e dato alle chiese da Giovanni stesso mentre era ancora in vita, così come un uomo di Ierapoli, di nome Papia e caro discepolo di Giovanni, ha riportato nei suoi cinque libri esegetici. In realtà, egli scrisse il Vangelo correttamente sotto dettatura di Giovanni. Ma l’eretico Marcione fu espulso da Giovanni, dopo essere stato da lui ripudiato a causa dei suoi sentimenti contrari. Egli aveva portato degli scritti, o delle lettere, dai fratelli del Ponto»
Va da sé che due testimonianze come queste, che indicano in Giovanni l’autore del testo in analisi, affermano implicitamente come la stesura del testo non possa certo essere fatta risalire ad una data successiva al 100 d.C.
Rimanendo a disposizione di tutti i lettori che volessero porre domande su quanto abbiamo visto, chiudiamo questa breve serie di approfondimenti legati alla confutazione dei deboli attacchi di Cascioli alla veridicità dei Vangeli canonici. Speriamo che le nostre considerazioni abbiano contribuito a fugare dubbi su questo argomento, sottolineando al contempo la «solidità storica» della Parola di Dio, che resiste inalterata alle accuse di sedicenti «esperti», i quali vengono inevitabilmente scoperti essere abili imbonitori con la missione di sviare le persone dal riconoscere nelle Sacre Scritture l’unico vero messaggio di vita e riconciliazione che il nostro Creatore ha voluto donarci.
Che Dio possa continuare ad illuminare la mente ed il cuore di tutti coloro che lo ricercano con cuore sincero, e voglia proteggerli dai «lupi rapaci» intenzionati a divorarli nel cammino.
 Girovagando per la rete, spinto anche dalle richieste di un lettore, mi sono «imbattuto» negli scritti di Luigi Cascioli, ex-sacerdote passato all’ateismo, che da anni ormai porta avanti una crociata contro la chiesa di Roma e contro il cristianesimo in generale, nel tentativo di dimostrare l’inconsistenza della fede cristiana. Ho quindi deciso di commentare in chiave critica alcuni suoi scritti, partendo dalle sue affermazioni relative ai Vangeli. Il primo testo del quale ci occuperemo è quello conosciuto come il «Vangelo secondo Marco».
Girovagando per la rete, spinto anche dalle richieste di un lettore, mi sono «imbattuto» negli scritti di Luigi Cascioli, ex-sacerdote passato all’ateismo, che da anni ormai porta avanti una crociata contro la chiesa di Roma e contro il cristianesimo in generale, nel tentativo di dimostrare l’inconsistenza della fede cristiana. Ho quindi deciso di commentare in chiave critica alcuni suoi scritti, partendo dalle sue affermazioni relative ai Vangeli. Il primo testo del quale ci occuperemo è quello conosciuto come il «Vangelo secondo Marco». 




 La lotta agli ordini religiosi veniva da lontano. Era stata uno dei principali obiettivi della politica giurisdizionalista settecentesca, condivisa da qualificati uomini di Chiesa, basti pensare al Muratori e, nel XVIi secolo, a Paolo Sarpi. L'abnorme proliferazione di monaci e frati, l'ozio, l'inosservanza di norme fondamentali della vita regolare sono temi frequenti, sotto forma di denuncia più o meno aspra, nella letteratura del tempo (...). Le soppressioni napoleoniche furono così l'epilogo di un braccio di ferro che era durato molti decenni. Bisogna aggiungere che la crisi della vita religiosa era indipendente dagli interventi dell'autorità politica e ben nota alla Santa Sede. Pio ix, proprio per rimediare a questo degrado, istituì la Congregazione sullo Stato degli Ordini Regolari (enciclica Ubi primum, del 1847).
La lotta agli ordini religiosi veniva da lontano. Era stata uno dei principali obiettivi della politica giurisdizionalista settecentesca, condivisa da qualificati uomini di Chiesa, basti pensare al Muratori e, nel XVIi secolo, a Paolo Sarpi. L'abnorme proliferazione di monaci e frati, l'ozio, l'inosservanza di norme fondamentali della vita regolare sono temi frequenti, sotto forma di denuncia più o meno aspra, nella letteratura del tempo (...). Le soppressioni napoleoniche furono così l'epilogo di un braccio di ferro che era durato molti decenni. Bisogna aggiungere che la crisi della vita religiosa era indipendente dagli interventi dell'autorità politica e ben nota alla Santa Sede. Pio ix, proprio per rimediare a questo degrado, istituì la Congregazione sullo Stato degli Ordini Regolari (enciclica Ubi primum, del 1847). Nella seconda tendenza rientra invece la legge 21 luglio 1848 che entrò in vigore con il Regio Decreto n. 777 del 25 agosto. Prescriveva la soppressione della Compagnia di Gesù, l'esproprio dei suoi beni, l'espulsione dei gesuiti "non regnicoli", cioè stranieri, l'obbligo per i "regnicoli" di uscire dall'ordine. Analoga sorte toccava alle Dame del Sacro Cuore, largamente diffuse nella Savoia.
Nella seconda tendenza rientra invece la legge 21 luglio 1848 che entrò in vigore con il Regio Decreto n. 777 del 25 agosto. Prescriveva la soppressione della Compagnia di Gesù, l'esproprio dei suoi beni, l'espulsione dei gesuiti "non regnicoli", cioè stranieri, l'obbligo per i "regnicoli" di uscire dall'ordine. Analoga sorte toccava alle Dame del Sacro Cuore, largamente diffuse nella Savoia.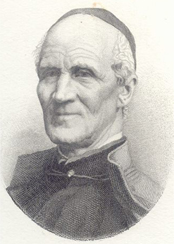 Il Piemonte cattolico era stato sconfitto dall'anticlericalismo intransigente della sinistra di Urbano Rattazzi, alla quale lo stesso Cavour aveva pagato un prezzo elevato. Sempre secondo Romeo, infatti, la legge del 1855 "rappresentò lo scostamento più sensibile" dalla politica liberale e separatista della formula "libera Chiesa in libero Stato". Scostamento che ebbe un effetto probabilmente non previsto dal legislatore: quello di aprire una breccia, di creare un precedente. La strada seguita allora, tutto sommato con cautela, diverrà la strada maestra della politica ecclesiastica italiana, ma senza più quelle prudenze. La linea anticlericale aveva vinto una battaglia decisiva.
Il Piemonte cattolico era stato sconfitto dall'anticlericalismo intransigente della sinistra di Urbano Rattazzi, alla quale lo stesso Cavour aveva pagato un prezzo elevato. Sempre secondo Romeo, infatti, la legge del 1855 "rappresentò lo scostamento più sensibile" dalla politica liberale e separatista della formula "libera Chiesa in libero Stato". Scostamento che ebbe un effetto probabilmente non previsto dal legislatore: quello di aprire una breccia, di creare un precedente. La strada seguita allora, tutto sommato con cautela, diverrà la strada maestra della politica ecclesiastica italiana, ma senza più quelle prudenze. La linea anticlericale aveva vinto una battaglia decisiva.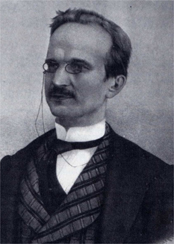 Si noti la scomparsa della distinzione fra istituti di vita contemplativa e di vita attiva, presente nel testo piemontese del 1855, distinzione che, se non altro, forniva un criterio. Venivano soppresse le relative case; ai membri delle comunità cancellate venivano riconosciuti i diritti civili e politici e una pensione annua; le monache potevano continuare a vivere nelle loro sedi, ma, se ridotte a sei, potevano essere trasferite e concentrate altrove a discrezione del Governo, che comunque, "in ogni tempo", si riservava tale facoltà, "per esigenze di ordine o di servizio pubblico". Ogni forma di resistenza sarebbe stata punita conformemente alle "leggi penali vigenti".
Si noti la scomparsa della distinzione fra istituti di vita contemplativa e di vita attiva, presente nel testo piemontese del 1855, distinzione che, se non altro, forniva un criterio. Venivano soppresse le relative case; ai membri delle comunità cancellate venivano riconosciuti i diritti civili e politici e una pensione annua; le monache potevano continuare a vivere nelle loro sedi, ma, se ridotte a sei, potevano essere trasferite e concentrate altrove a discrezione del Governo, che comunque, "in ogni tempo", si riservava tale facoltà, "per esigenze di ordine o di servizio pubblico". Ogni forma di resistenza sarebbe stata punita conformemente alle "leggi penali vigenti". Proseguo in questo articolo, come promesso, l’analisi critica delle tesi di Luigi Cascioli in merito alla veridicità dei quattro Vangeli canonici, che l’ex-sacerdote afferma essere imposture. L’ultima volta abbiamo visto alcune note sul Vangelo di Marco, mentre in questa istanza ci occuperemo di quello di Matteo, il pubblicano che fu accolto al seguito di Cristo.
Proseguo in questo articolo, come promesso, l’analisi critica delle tesi di Luigi Cascioli in merito alla veridicità dei quattro Vangeli canonici, che l’ex-sacerdote afferma essere imposture. L’ultima volta abbiamo visto alcune note sul Vangelo di Marco, mentre in questa istanza ci occuperemo di quello di Matteo, il pubblicano che fu accolto al seguito di Cristo. In questa terza parte del nostro scritto, analizziamo la posizione dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito alla veridicità ed affidabilità del terzo vangelo canonico, ossia quello avente la firma di Luca, autore, tra l’altro degli Atti degli Apostoli. Come già fatto in precedenza, prima di passare alla confutazione delle argomentazioni del Cascioli, vediamo alcune informazioni relative al vangelo stesso, per poi calarci nella trattazione storico/biblica di quanto l’ex-sacerdote afferma, e dimostrare anche in questo caso come gli attacchi al Testo Sacro si rivelino consistenti come bolle di sapone, che non possono sussistere davanti ad una analisi seria.
In questa terza parte del nostro scritto, analizziamo la posizione dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito alla veridicità ed affidabilità del terzo vangelo canonico, ossia quello avente la firma di Luca, autore, tra l’altro degli Atti degli Apostoli. Come già fatto in precedenza, prima di passare alla confutazione delle argomentazioni del Cascioli, vediamo alcune informazioni relative al vangelo stesso, per poi calarci nella trattazione storico/biblica di quanto l’ex-sacerdote afferma, e dimostrare anche in questo caso come gli attacchi al Testo Sacro si rivelino consistenti come bolle di sapone, che non possono sussistere davanti ad una analisi seria. In questo quarto ed ultimo articolo, dedicato alla confutazione delle tesi dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito ai Vangeli canonici, abbiamo deciso di adottare uno stile leggermente differente rispetto ai tre articoli precedenti: mentre nel caso dei tre sinottici abbiamo prima presentato una sorta di “scheda riepilogativa” di ciascun Vangelo, contenente alcune informazioni sui vari testi, e solo in seguito ci siamo calati nella critica delle accuse, questa volta affronteremo direttamente la confutazione di quanto proposto dal Cascioli, fornendo mano a mano le nozioni utili a comprendere quanto trattato.
In questo quarto ed ultimo articolo, dedicato alla confutazione delle tesi dell’ex-sacerdote Luigi Cascioli in merito ai Vangeli canonici, abbiamo deciso di adottare uno stile leggermente differente rispetto ai tre articoli precedenti: mentre nel caso dei tre sinottici abbiamo prima presentato una sorta di “scheda riepilogativa” di ciascun Vangelo, contenente alcune informazioni sui vari testi, e solo in seguito ci siamo calati nella critica delle accuse, questa volta affronteremo direttamente la confutazione di quanto proposto dal Cascioli, fornendo mano a mano le nozioni utili a comprendere quanto trattato.